
RASSEGNA STAMPA DETTI E SCRITTI
19 LUGLIO 2021
A cura di Manlio Lo Presti
Esergo
La maggior parte degli uomini crede di riflettere su una cosa se ci ragiona sopra.
MARTIN HEIDEGGER, Note I-V. Quaderni neri 1942-1948, Bompiani, 2018, pag. 35
https://www.facebook.com/dettiescritti
https://www.instagram.com/dettiescritti/
Le opinioni degli autori citati possono non coincidere con la posizione del curatore della presente Rassegna.
I numeri degli anni precedenti della Rassegna sono disponibili sul sito www.dettiescritti.com
Precisazioni legali
www.dettiescritti.com è un blog intestato a Manlio Lo Presti, e-mail: redazionedettiescritti@gmail.com
Il blog non effettua alcun controllo preventivo in relazione al contenuto, alla natura, alla veridicità e alla correttezza di materiali, dati e informazioni pubblicati, né delle opinioni che in essi vengono espresse. Nulla su questo blog è pensato e pubblicato per essere creduto acriticamente o essere accettato senza farsi domande e fare valutazioni personali.
Le immagini e le foto presenti nel Notiziario, pubblicati con cadenza pressoché giornaliera, sono raccolte dalla rete internet e quindi di pubblico dominio. Le persone interessate o gli autori che dovessero avere qualcosa in contrario alla pubblicazione delle immagini e delle foto, possono segnalarlo alla redazione scrivendo alla e-mail redazionedettiescritti@gmail.com
La redazione provvederà doverosamente ed immediatamente alla loro rimozione dal blog.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
SOMMARIO
EDITORIALE
IN EVIDENZA
Il Covid come strategia di totalitarismo biopolitico globale
Due stimati accademici italiani firmano insieme un libro-denuncia.
Esce in questi giorni per le Edizioni La Vela di Lucca un libro che sarà destinato a far parlare di sé, perché a firmarlo non sono due pericolosi sovversivi, né due individui improvvisatisi in quattro e quattr’otto scrittori e opinionisti, bensì due stimati professori universitari, tra i pochissimi – non viene in verità in mente nessun altro nome… – che si sono esposti pubblicamente in questo anno e mezzo nel generale e imbarazzante silenzio dell’Accademia (un tempo sede del libero pensiero) e che hanno rischiosamente manifestato il proprio dissenso critico nei confronti della narrazione pandemica: Luca Marini e Francesco Benozzo. Il libro ha per titolo COVID. Prove tecniche di totalitarismo (266 pagg.)
Ecco qua, succintamente, il profilo accademico dei due autori, a beneficio di chi, sulla scorta di campagne nazionali anti fake-news come quella intitolata “Io non la bevo”, si premura di verificare se le tesi esposte da qualche “complottista” provengono “da fonti attendibili” oppure da personaggi sconosciuti trasformatisi in “leoni da tastiera”.
Francesco Benozzo, già noto ai lettori di CDC per i numerosi suoi interventi pubblicati sul nostro sito, insegna Filologia all’Università di Bologna, è il coordinatore del dottorato di ricerca in “Studi letterari e culturali”, dirige tre riviste scientifiche internazionali di linguistica e antropologia, è il responsabile di alcuni centri di studio dedicati alla filologia comparata e all’origine del linguaggio (uno dei quali patrocinato UNESCO), è membro del comitato direttivo o scientifico di numerosi progetti inter-universitari, ha all’attivo oltre 700 pubblicazioni scientifiche. Per la sua attività di poeta epico-performativo, poi, è stato candidato dal Pen International al Premio Nobel per la Letteratura, a partire dal 2015.
Luca Marini è professore di Diritto internazionale e Diritti umani e bioetica all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, è stato coordinatore scientifico nazionale del “Progetto di rilevante interesse nazionale” sul principio di precauzione, componente del comitato scientifico della Società italiana per la bioetica e della Commissione di studio sulla bioetica del CNR, direttore del Master in bioetica, biodiritto e bioeconomia della Sapienza, vice presidente del Comitato per la Bioetica e delegato italiano presso il Comitato direttivo per la bioetica del Consiglio d’Europa; attualmente è presidente dell’European Centre for Science, Ethics and Law (ECSEL).

Il libro è oltretutto pubblicato con il contributo della Commissione europea, attraverso un finanziamento di una delle prestigiose Cattedra Jean Monnet di biodiritto “European Law of Bioethics” (EULaB II), di cui è stato insignito Marini, per ben tre volte, come riconoscimento per i suoi meriti scientifici.
La tesi dei due autori – di cui Benozzo si era già fatto in parte sostenitore nei suoi due libri Poesia, scienza e dissidenza (Bologna, Clueb, 2020) e Memorie di un filologo complottista (Lucca, Edizioni La Vela, 2021) – è chiara, ed è sostenuta con toni fermi e argomentazioni stringenti, attraverso una disamina giuridica e un’analisi filologica: la situazione in atto è il lampante inveramento di una forma di totalitarismo biopolitico globale. Il volume è formato da tre parti: un primo lungo e documentato saggio di Marini intitolato Il paziente zero, che riscostruisce in modo alternativo e rigoroso le vicende degli ultimi 15 mesi; una parte antologica centrale (Piccola antologia di consapevolezza critica), che riproduce, come in una cronaca dell’emergenza, interventi apparsi su un blog curato dallo stesso Marini a partire dal 2019; un saggio finale di Benozzo dal titolo Cerbero e Orfeo. Un’analisi narratologica dello stato di emergenza in atto, dove si mostra come la versione ufficiale dei fatti sfugga, per il suo carattere ambiguo e incoerente, a qualsiasi pretesa di plausibilità e verosimiglianza.
Di Francesco Benozzo, pubblicato da Giulio Bona per ComeDonChisciotte.org
FONTE: https://comedonchisciotte.org/il-covid-come-strategia-di-totalitarismo-biopolitico-globale/
Paradigma Covid: collasso sistemico e fantasma pandemico
di Fabio Vighi
 A un anno e mezzo dall’arrivo di Virus, qualcuno forse si sarà chiesto perché la classe dominante, per sua natura senza scrupoli, abbia messo nel congelatore la macchina del profitto a fronte di un patogeno che si accanisce quasi esclusivamente contro i soggetti improduttivi – quegli ultra-ottantenni che, tra l’altro, da tempo mettono a dura prova il sistema pensionistico. Perché, improvvisamente, tutto questo zelo? Cui prodest? Solo chi non conosce le mirabolanti avventure di GloboCap (capitalismo globale) può illudersi che il sistema chiuda i battenti per spirito caritatevole. Ai grandi predatori del petrolio, delle armi, e dei vaccini, non frega proprio niente dell’umanità.
A un anno e mezzo dall’arrivo di Virus, qualcuno forse si sarà chiesto perché la classe dominante, per sua natura senza scrupoli, abbia messo nel congelatore la macchina del profitto a fronte di un patogeno che si accanisce quasi esclusivamente contro i soggetti improduttivi – quegli ultra-ottantenni che, tra l’altro, da tempo mettono a dura prova il sistema pensionistico. Perché, improvvisamente, tutto questo zelo? Cui prodest? Solo chi non conosce le mirabolanti avventure di GloboCap (capitalismo globale) può illudersi che il sistema chiuda i battenti per spirito caritatevole. Ai grandi predatori del petrolio, delle armi, e dei vaccini, non frega proprio niente dell’umanità.
Quale emergenza?
Prima di entrare nel vivo della discussione facciamo un passo indietro all’estate 2019, quando l’economia mondiale, a 11 anni dal collasso del 2008, era di nuovo sull’orlo di una crisi di nervi.
Giugno 2019: La ‘Banca dei Regolamenti Internazionali’ (BRI), potentissima ‘banca centrale di tutte le banche centrali’, con sede a Basilea, lancia un grido d’allarme sulla sostenibilità del settore finanziario. Nel suo Rapporto Annuale la BRI evidenzia il forte rischio di “surriscaldamento […] nel mercato dei prestiti a leva”, dove “gli standard del credito si sono deteriorati” e “sono aumentate le obbligazioni garantite da collaterale (CLO).” Si tratta di prestiti erogati a società iper-indebitate che vengono poi messi sul mercato come bond. In parole povere, la pancia dell’industria finanziaria è di nuovo piena di spazzatura.
9 agosto 2019: Sempre la BRI pubblica un working paper in cui si chiedono esplicitamente “misure non convenzionali di politica monetaria” finalizzate a “isolare l’economia reale da un ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie”.
15 agosto 2019: BlackRock, il fondo di investimento più potente al mondo, pubblica un documento ufficiale in cui si ‘suggerisce’ alla Federal Reserve di iniettare liquidità direttamente nel sistema finanziario per prevenire “una drammatica recessione”. Confermando l’allarme della BRI, BlackRock sostiene che “è necessaria una risposta senza precedenti”, ovvero “un’azione diretta [going direct]”, da parte della banca centrale. Un piano che, come tale, comporta un rischio ben preciso: “l’iperinflazione. Gli esempi includono la Repubblica di Weimar negli anni ’20, così come, più di recente, l’Argentina e lo Zimbabwe.”
22-24 agosto 2019: I banchieri centrali del G7 si incontrano a Jackson Hole, nel Wyoming, per discutere il suddetto documento di BlackRock a fronte di una crescente volatilità finanziaria. James Bullard, presidente della Federal Reserve di St Louis, afferma: “Dobbiamo smettere di pensare che il prossimo anno le cose saranno normali”.
15-16 settembre 2019: La crisi finanziaria viene ufficialmente inaugurata da un picco dei tassi repo, che schizzano dal 2% al 10,5% nel giro di poche ore. ‘Repo’ sta per repurchase agreement, contratto finanziario in cui i grandi fondi di investimento prestano denaro dietro collaterale (tipicamente bond governativi). Al momento dello scambio, l’operatore finanziario (banca) si impegna a riacquistare il collaterale a un prezzo più alto, tipicamente nel giro di poche ore (overnight). In breve, i repo sono prestiti garantiti, l’equivalente dei nostri ‘pronti contro termine’. Fanno parte dello shadow banking system, gigantesco apparato di intermediazione finanziaria parallelo e complementare alla rete tradizionale, ma libero da vincoli di vigilanza. La funzione dei repo è consentire alle banche di ottenere liquidità a breve termine per rimanere attive nel settore speculativo, soprattutto nella galassia dei derivati. Una mancanza di liquidità nei repo, che solo negli USA muovono circa 3.000 miliardi di dollari al giorno, può scatenare una devastante reazione a catena su tutti i principali mercati. L’impennata dei tassi nella notte tra il 15 e il 16 settembre 2019 finisce per prosciugare l’erogazione del credito. La notizia fa il giro del mondo (vedi qui, qui, e qui) ma viene sottostimata dal mainstream.
17 settembre 2019: La Fed inaugura un programma monetario emergenziale che prevede la creazione settimanale di centinaia di miliardi di dollari da iniettare nel sistema finanziario, esattamente come suggerito da BlackRock. Non sorprende che, nel marzo 2020, la Fed affidi proprio a BlackRock la gestione del pacchetto di salvataggio in risposta alla ‘crisi pandemica’.
18 ottobre 2019: a New York viene simulata una pandemia zoonotica globale nell’ormai celebre Event 201, esercizio strategico coordinato dal Johns Hopkins Biosecurity Center e dalla Bill and Melinda Gates Foundation.
21-24 gennaio 2020: A Davos, in Svizzera, il World Economic Forum (WEF) discute di economia e di vaccini.
23 gennaio 2020: La Cina chiude Wuhan insieme a altre città della provincia di Hubei.
11 marzo 2020: Il direttore generale dell’OMS definisce il Covid-19 una pandemia. Il resto è storia.
Se colleghiamo i fatti sopracitati, emerge un’ipotesi riassumibile nel modo seguente: i lockdown, e dunque la sospensione globale delle transazioni economiche, hanno permesso alla Fed di inondare i mercati finanziari di denaro fresco di stampa arginando il rischio iperinflazione, che si sarebbe scatenata se quella massa di denaro avesse raggiunto l’economia reale. Tra settembre 2019 e marzo 2020 la Fed ha pompato più di 9.000 miliardi di dollari nel sistema interbancario, pari a più del 40% del PIL statunitense.
Per comprendere le ragioni della pandemia dobbiamo inserirla nel contesto economico che le spetta. Pochi mesi prima della comparsa del SARS-CoV-2, la Fed stava cercando di domare l’incendio che divampava nel sistema interbancario. Sappiamo che nel magico mondo della finanza, tout se tient. Uno battito d’ali di farfalla in un certo settore può far crollare l’intero castello di carte; a maggior ragione in un sistema drogato di debito, sorretto cioè da credito erogato a tassi vicini o pari a zero. Se lasciato al suo corso, l’incendio avrebbe contagiato i cicli economici globali legati a produzione e distribuzione, attraverso un effetto domino di insolvenze e default di tale portata da minare persino la tenuta del dollaro quale valuta di riserva globale.
Ci sono buone ragioni per sospettare che la crisi di liquidità nei circuiti finanziari fosse divenuta esiziale, al punto da imporre l’extrema ratio del congelamento dell’economia. Solo un coma economico indotto avrebbe garantito alla Fed lo spazio d’azione necessario a sbrogliare la matassa finanziaria. Dietro il paravento pandemico la Fed ha lavorato alacremente a tappare le voragini apertesi nel sistema dei prestiti interbancari, aggirando sia l’iperinflazione che il Financial Stability Oversight Council (agenzia federale per il monitoraggio del rischio finanziario creata nel 2010). Come ha scritto l’economista Ellen Brown, si sarebbe trattato di un altro bailout (salvataggio), ma questa volta sotto le mentite spoglie di un virus. John Titus, che da anni vigila sulle operazioni della banca centrale americana, non ha dubbi: “La pandemia virale è la narrazione di copertura [cover story] che ha permesso alla Fed di dare il via al piano BlackRock con un’ondata di acquisti massicci e del tutto senza precedenti.” Altri sono arrivati alla medesima conclusione.
In questa sede non importa stabilire dove esattamente si trovasse la miccia, perché quando l’aria è satura di materiali infiammabili qualsiasi scintilla può causare l’esplosione. Preme piuttosto constatare che nell’autunno del 2019 il sistema finanziario avesse raggiunto un’altra volta il punto di non ritorno. La vulgata del mainstream andrebbe dunque rovesciata: la finanza non è crollata perché è stato necessario imporre i lockdown; piuttosto, è stato necessario imporre i lockdown perché la finanza stava crollando. Il congelamento delle transazioni commerciali ha infatti drenato la circolazione del denaro e la richiesta di credito. Ciò ha permesso la ristrutturazione dell’architettura finanziaria attraverso manovre monetarie straordinariamente aggressive, possibili solo all’ombra di un’economia bloccata. E se oggi si comincia a riaprire, lo si fa con estrema cautela, evocando ‘varianti’ che andrebbero interpretate come sintomi dissimulati del rischio inflazionistico, autentica spade di Damocle da cui non si capisce come potremo liberarci.
A mio modo di vedere siamo di fronte a un cambio di paradigma. La gestione autoritaria di economia e società si impone come condizione necessaria alla sopravvivenza (distopica) del capitalismo stesso, che non è più in grado di riprodursi attraverso il lavoro salariato di massa e l’annessa utopia consumistica. L’agenda che ha partorito il fantasma della pandemia come religione sanitario-vaccinale nasce dalla percezione della sopravvenuta impraticabilità di un capitalismo a base liberal-democratica. Mi riferisco al crollo di redditività di un modello industriale reso obsoleto dall’automazione tecnologica, e per questo sempre più vincolato a debito pubblico, bassi salari, centralizzazione di ricchezza e potere, stato d’emergenza permanente, e alla creatività del settore finanziario, dove il denaro si moltiplica da sé, per partenogenesi.
Se partiamo da questo assunto, noteremo che il blocco dell’economia subdolamente attribuito all’emergenza sanitaria ha ottenuto risultati tutt’altro che disprezzabili in termini capitalistici. Ne sottolineo rapidamente quattro: 1) Ha permesso alla Fed di riorganizzare il settore finanziario grazie alla stampa di miliardi di dollari a getto continuo; 2) Ha accelerato il processo di estinzione delle piccole e medie imprese, consentendo ai maggiori gruppi di potere di monopolizzare i flussi di commercio, legandoli alle politiche monetarie delle banche centrali; 3) Ha ulteriormente alleggerito il costo del lavoro, facilitando inoltre cospicui risparmi attraverso lo smart working (che è smart soprattutto per chi lo impone); 4) Ha favorito la crescita dell’e-commerce, l’esplosione dei Big Tech, e la proliferazione del farma-dollaro – inclusa la tanto denigrata industria della plastica, che ora produce milioni di mascherine e guanti alla settimana, molti dei quali finiscono in mare (per la gioia dei green new dealers). Nel solo 2020, la ricchezza dei circa 2.200 miliardari del pianeta è cresciuta di 1.9 trilioni di dollari, aumento senza precedenti storici. Tutto ciò grazie a un virus talmente devastante che, stando ai dati ufficiali (OMS), almeno il 99.8% degli ‘infetti’ guarisce.
L’ipotesi del motivo economico deve dunque essere inserita in un più ampio e complesso contesto di trasformazione sociale. Lo scenario che ci si prospetta, se solleviamo il velo di Maya, è di carattere marcatamente neo-feudale. Masse di consumatori sempre meno produttive vengono regimentate, semplicemente perché i nuovi glebalizzatori non sanno più che farsene. Insieme ai sottoccupati e agli esclusi, il ceto medio impoverito diventa un problema da gestire con il bastone del lockdown (a breve anche in versione climatica), del coprifuoco, della propaganda, e della militarizzazione della società, piuttosto che con la carota del lavoro, del consumo, della democrazia partecipativa, dei diritti sociali (sostituiti nell’immaginario collettivo dai diritti civili delle minoranze), e delle ‘meritate vacanze’.
È dunque da illusi pensare che lo scopo delle chiusure sia terapeutico e umanitario. Quando mai il capitale si è preso cura dei suoi sudditi? Indifferenza e misantropia sono da sempre i tratti tipici del nostro modo di produzione, la cui unica vera passione è il profitto, e il potere che ne deriva. Oggi la classe dominante fa capo ai tre maggiori fondi di investimento al mondo: BlackRock, Vanguard e State Street Global Advisor. Questi giganti, posizionati al centro di un’enorme galassia di entità finanziarie, gestiscono una massa di valore vicina alla metà del PIL globale, e sono i maggiori azionisti in circa il 90% delle società quotate in borsa. Attorno a loro gravitano istituzioni transnazionali come il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, il Forum Economico Mondiale, la Commissione Trilaterale, e la Banca dei Regolamenti Internazionali, la cui funzione è coordinare il consenso all’interno della costellazione finanziaria. Non è difficile ipotizzare che in tale ambito vengano prese tutte le principali decisioni strategiche, non solo di carattere economico ma anche politico e militare.
D’altra parte, come potremmo fidarci di un mega cartello farmaceutico (l’OMS) che si occupa non di ‘salute pubblica’, ma di commercializzare prodotti privati in tutto il mondo alle tariffe più redditizie possibili? I problemi di salute pubblica, semmai, derivano da condizioni di lavoro ignobili, cattiva alimentazione, inquinamento di aria, acqua e cibo, e soprattutto da una dilagante povertà; eppure nessuno di questi ‘patogeni’ rientra nella lista delle preoccupazioni umanitarie dell’OMS. L’enorme conflitto di interesse tra i predatori lombrosiani dell’industria farmaceutica, le agenzie mediche nazionali e sovranazionali, e gli esecutori politici, è ormai un segreto di Pulcinella. Non deve stupire che il giorno in cui l’OMS ha classificato COVID-19 come pandemia, il WEF, insieme all’OMS stessa, ha lanciato la Covid Action Platform, una coalizione per la “protezione della vita” gestita da oltre 1.000 tra le aziende private più potenti al mondo.
Mettiamoci in testa che l’unica cosa che conta per chi dirige l’orchestra emergenziale è soddisfare la fame di profitto e potere, e dunque ogni mossa è programmata in tal senso. D’altronde, se chi produce armi provoca guerre, chi produce farmaci deve inventarsi malattie. Non a caso la ‘salute pubblica’ è il settore di gran lunga più remunerativo dell’economia mondiale, al punto che Big Pharma spende circa tre volte più di Big Oil e il doppio di Big Tech in finanziamenti lobbistici. La domanda potenzialmente infinita di vaccini e intrugli genici vari offre ai cartelli farmaceutici la prospettiva di flussi di profitto pressoché illimitati, specie quando garantiti da programmi di vaccinazione di massa sovvenzionati da denaro pubblico (altro debito che ricadrà sulle nostre teste).
Perché tutte le cure precoci al Covid, dall’efficacia comprovata, sono state criminosamente sabotate? Come ammette candidamente la FDA (Food & Drug Administration, organo ufficiale americano in materia di salute pubblica) l’utilizzo di vaccini emergenziali è possibile solo se “non ci sono alternative adeguate, approvate e disponibili”. Le terapie domiciliari avrebbero aiutato a ridurre i ricoveri, mettendo fine all’emergenza ospedaliera. Ma l’operazione Covid mira a salvaguardare i privilegi economici, non la salute dei cittadini. Chi ancora si ostina a negarlo diventa complice di un sistema che, per sopravvivere, deve terrorizzare.
D’altra parte, la messinscena emergenziale attecchisce grazie a un palese difetto democratico, che si evidenzia nella feroce manipolazione dell’opinione pubblica. Ogni ‘dibattito pubblico’ è spudoratamente privatizzato, ovvero monopolizzato dalla religiosa osservanza di un Verbo tecnico-scientifico a libro paga delle élites economiche. Ogni ‘libera discussione’ è legittimata dall’adesione a postulati pseudo-scientifici accuratamente depurati sia dal contesto socio-economico che dalla possibilità del dubbio e del confronto. Il pensiero unico dei virologi di regime, talmente bislacchi da cambiare opinione con la frequenza con cui si cambiano i calzini, si fonda sulla censura di premi Nobel come Luc Montaigner, o giganti della microbiologia come Didier Raoult; per non citare dozzine di altre eccellenze scientifiche silenziate dal mainstream.
La salute pubblica privatizzata è da tempo un mezzo di ingegneria sociale, oltre che di leva economica. Si può dire che abbia sostituito la religione come avanguardia ideologica dell’imperialismo capitalista, come ben comprese il filantropo Frederick T. Gates, nonno di Bill e principale consigliere commerciale del grande industriale del petrolio John Rockefeller. Nel 1901, Gates nonno convinse Rockefeller a fondare una struttura di ricerca di medicina sperimentale contro le malattie infettive, il Rockefeller Institute for Medical Research (poi Rockefeller University) – buon sangue non mente.
In breve, per COVID-19 non ci è difficile immaginare il seguente quadro strategico. Si prepara una narrazione fittizia sulla base di un potenziale rischio epidemico presentato in modo tale da favorire comportamenti di estrema sottomissione. Per far questo basta un virus influenzale di ambigua collocazione epidemiologica, su cui costruire un’aggressiva narrazione di contagio relazionabile a aree geografiche in cui è alto l’impatto di polmoniti e malattie respiratorie o vascolari nella popolazione anziana e immunodepressa, magari con l’aggravante del forte inquinamento. Non c’è neppure bisogno di inventarsi granché, visto che le terapie intensive in paesi ‘avanzati’ come l’Italia erano già al collasso negli anni precedenti all’arrivo del Covid, con picchi di mortalità per i quali nessuno si era però sognato di riesumare la quarantena.
Ma questa volta si fa sul serio: si dichiara uno stato di emergenza che scatena il panico generalizzato, l’intasamento di pronto soccorso, ospedali e case di cura (in Italia, le sole infezioni ospedaliere causano circa 50.000 decessi annui), l’applicazione di nefasti protocolli terapeutici, e la sospensione della medicina di base. In queste condizioni, la pandemia diventa una profezia che si auto-avvera. La propaganda che impazza nei centri nevralgici del potere finanziario (Nord America e Europa zona Euro) è da subito essenziale al mantenimento dello stato di crisi, accettato come unica forma possibile di razionalità politico-esistenziale. Le moltitudini esposte a bombardamento mediatico non solo si piegano, ma addirittura si auto-disciplinano, aderendo con grottesco entusiasmo identitario a forme di civismo in cui la coercizione diventa altruismo, a tal punto che la lotta per il bene comune resuscita persino la pratica infame della delazione.
Ai registi del piano pandemico va dunque riconosciuta una certa sadica genialità, per quanto il crimine non possa dirsi perfetto. Da un punto di vista dialettico, qualsiasi forma di dominio che ambisce a totalizzarsi è destinata a fallire, e questo vale anche per i burattinai della finanza, e tutti i pupazzi di cui si servono per tenere in piedi l’operazione di guerra psicologica che ipnotizza le masse da più di un anno. Il potere, in fondo, tende sempre a illudersi sulla propria onnipotenza, innanzitutto perché, paradossalmente, è anch’esso eterodiretto. Oggi, le decisioni prese da chi siede nella stanza dei bottoni hanno come fine la riproduzione dell’ingranaggio socio-economico che chiamiamo ‘capitalismo’. Il potere, in altre parole, è la macchina impersonale del profitto, il cui unico scopo è continuare la sua folle corsa. E nell’attuale fase storica, lo stato d’emergenza globale rappresenta l’assetto politico che meglio garantisce la riproducibilità del dispositivo economico, indipendentemente da chi lo sta pilotando e dalle contraddizioni generate.
La grande simulazione, ovvero: presi per il Covid
Chiunque abbia conservato un minimo di indipendenza intellettuale dai media di regime dovrebbe aver compreso che l’emergenza da coronavirus è un artefatto. Di seguito farò un breve inventario delle principali evidenze di cui disponiamo.
Come ammesso dall’OMS, il tasso di letalità del misterioso patogeno, che colpisce quasi esclusivamente soggetti anziani affetti da comorbidità gravi, è paragonabile a quello di un’influenza stagionale (0.23% a fine 2020, e 0.15% a marzo 2021). Nulla a che vedere con le stime monstre di Neil Ferguson, padre di tutti i modellisti apocalittici sponsorizzati da Big Pharma. A causa della sua bassa letalità, SARS-CoV-2 rientra nel penultimo livello dei cinque stilati dalle autorità sanitarie statunitensi; un livello che, secondo le linee guida dell’OMS, richiede solo l’isolamento facoltativo dei malati, mentre esclude categoricamente misure emergenziali come lockdown, mascherine, chiusura delle scuole, distanziamento, e vaccinazioni. O meglio, le escludeva fino a quando non si sono cambiate le carte in tavola per legittimare la più grande campagna vaccinale di tutti i tempi, la cui assurdità è riassumibile nella seguente domanda: perché l’umanità intera (inclusi i bambini!) dovrebbe iniettarsi un siero sperimentale dagli effetti avversi sempre più inquietanti e fuori norma,1 quando almeno il 99.8% dei contagiati, di cui la stragrande maggioranza asintomatici, guarisce? La risposta è lapalissiana: perché i vaccini sono il vitello d’oro del terzo millennio, e l’umanità-gregge è carne da profitto di ‘ultima generazione’, ovvero in versione cavia.
Proprio alle cavie parlava Mario Draghi (l’uomo della provvidenza delle banche) inaugurando il Global Health Summit di Roma il 21 maggio scorso: “dobbiamo vaccinare il mondo contro il coronavirus, e farlo velocemente”. Parole sante, subito ribadite in accorato appello da Ezio Mauro: “abbiamo il dovere di salvare il mondo.” In un esercizio di impareggiabile ipocrisia, Mauro ci dice che “il gap tra i Paesi Poveri e i Paesi Ricchi si supera con un’inversione culturale”, che ovviamente consiste nell’abbracciare la teologia dell’universalismo vaccinale: “All’universale si risponde solo con l’universale”. Amen, con buona pace di Hegel.
Per chi non lo sapesse, in Europa il passaporto sanitario digitale era stato programmato nel 2018, con attuazione prevista per il 2022. A ridosso dalla ‘pandemia’ si erano tenuti grandiosi eventi promozionali come il Global Vaccination Summit (Commissione Europea, Bruxelles, 12 settembre 2019); e il Global Vaccine Safety Summit (OMS, Ginevra, 2-3 dicembre 2019). Negli USA, il 19 settembre 2019 Donald Trump firmava l’Ordine Esecutivo 13887, in cui veniva istituita una Task Force con l’obiettivo di lanciare un “piano nazionale quinquennale per la promozione dell’uso di tecnologie vaccinali più agili e scalabili” per contrastare l’impatto di “una pandemia influenzale”, che, “può diffondersi rapidamente in tutto il mondo, infettare un numero maggiore di persone e causare alti tassi di malattia e morte nelle popolazioni senza immunità”. Insomma, la tavola era stata apparecchiata con largo anticipo.
Basta poi osservare che la sintomatologia ufficiale del Covid e delle sue varianti (stanchezza, febbre, tosse secca, perdita di gusto e olfatto, ecc.) è talmente generica che tutti, anche i più sani, vi si possono riconoscere al primo sternuto; allo stesso tempo, rende la malattia facilmente riclassificabile come causa di decesso di chi sarebbe comunque passato a miglior vita, sia per anagrafe che per quadro patologico ampiamente compromesso. La stessa trasmissione per via respiratoria si sposa perfettamente con le ragioni dell’isolamento, per giustificare il quale si arriva persino a inventare la categoria molieriana del ‘malato asintomatico’.
C’è poi il punto dirimente, la leva di Archimede del ‘paradigma corona’. Tutta la sceneggiatura pandemica – dalla ‘curva del contagio’ ai ‘decessi da Covid’ – si regge sulla farsa del test PCR, strumento autorizzato alla rilevazione del SARS-CoV-2 da uno studio prodotto in tempi record dall’equipe del virologo berlinese Christian Drosten, su commissione dell’OMS. Come molti ormai sapranno, l’inaffidabilità diagnostica del test PCR fu già denunciata dal suo stesso inventore, il premio Nobel Kary Mullis (malauguratamente scomparso il 7 agosto 2019), e di recente ribadita, tra gli altri, da 22 esperti di fama internazionale che hanno chiesto lo stralcio dello studio in questione per evidenti difetti scientifici. Ovviamente la richiesta è caduta nel vuoto.
Autentico motore della pandemia, il test PCR (tampone) si presta a essere abusato in modo simile a come da bambini si abusava del termometro al mercurio, mettendolo sul termosifone per fingere la febbre e saltare la scuola. Si tratta di uno strumento che funziona attraverso gli ormai celebri ‘cicli di amplificazione’ (cycle thresholds): più se ne fanno, più si sfornano falsi positivi, come incautamente ammesso persino dal guru Anthony Fauci quando ha affermato che sopra i 35 cicli i tamponi non hanno alcun valore. Orbene, perché durante la pandemia, nei laboratori di tutto il mondo, si sono fatti di norma amplificazioni pari o superiori a 35 cicli? Persino il New York Times – non certo un covo di pericolosi negazionisti – l’estate scorsa aveva sollevato la questione.
Grazie alla sensibilità del tampone la pandemia si può aprire e chiudere come un rubinetto, cosa che permette al regime sanitario di esercitare un controllo assoluto sul mostro numerologico del contagio e della mortalità da Covid – gli strumenti chiave del terrore quotidiano. Così non deve stupire che nel gennaio del 2021, a inizio campagna vaccinale, l’OMS abbia messo in guardia sul rischio dei falsi positivi generati dall’uso improprio del test. A conferma di questa nuova prassi, nell’aprile-maggio di quest’anno il CDC americano ha chiesto sia di abbassare il numero dei cicli PCR laddove si sospettassero nuove infezioni, che di sospendere la conta delle infezioni asintomatiche o lievi di coloro che sono stati vaccinati. Tutto ciò per dimostrare che i vaccini funzionano.
Ricordiamo poi che a gonfiare la bolla dei decessi ha contribuito l’introduzione di nuovi protocolli medici (marzo 2020) che istruiscono a certificare ‘COVID-19’ come causa di morte anche laddove si presume abbia causato o contribuito al decesso, e senza necessità di verifica clinica. Lo scrive l’OMS ai medici legali: “applicate sempre queste istruzioni, che siano corrette o meno dal punto di vista medico”; e lo ratifica l’ISTAT: “anche se non c’è una diagnosi confermata.” Interessante, poi, come il Covid abbia ‘curato’ l’influenza, che è miracolosamente scomparsa. È stato inoltre dimostrato che la trasmissione asintomatica è statisticamente inesistente, e che i lockdown sono sia inefficaci che socialmente distruttivi, non ultimo nel causare migliaia di decessi attraverso la sospensione delle cure mediche. Sappiamo, per ammissione dello stesso CDC americano, e della Commissione Europea, che il patogeno in questione non è mai stato isolato né purificato, e che quindi ci si presenta con tutti i crismi di un virus-fantasma.
Se ciò non bastasse, pensiamo per un attimo all’evoluzione del significato di pandemia prima del 2020, rispetto all’influenza aviaria (2003) e alla suina (2009). Nel corso di quest’ultima, l’OMS decise di cambiare la definizione del termine, eliminando il riferimento all’“alta mortalità”. In sostanza, “diffusione epidemica di una malattia” divenne criterio sufficiente a far scattare l’allarme pandemico, insieme ai succulenti contratti vaccinali. E se aviaria e suina non portarono le vagonate di morti pronosticati dagli apprendisti stregoni dell’industria farmaceutica (celebri i 150 milioni di decessi pronosticati da David Nabarro, OMS, riguardo l’aviaria), furono comunque funzionali sia a sdoganare il business miliardario di mascherine, vaccini et similia, che nell’introdurre nelle popolazioni il tarlo del virus apocalittico, che ci attende sulla soglia di casa nonché ogni volta che incrociamo altri esemplari di Homo pandemicus; e dal quale, pare, non ci libereremo mai.
Negli ultimi anni, l’attesa per il grande evento era divenuta spasmodica, a un punto tale che si era preso a simularla, come in un blockbuster hollywoodiano: prima con il Clade X (maggio 2018), poi con il già citato Event 201 (ottobre 2019), esercizi strategici promossi dal WEF dell’ubermensch Klaus Schwab in collaborazione con il centro di biosicurezza della Johns Hopkins University e con l’immancabile Bill and Melinda Gates Foundation. Peraltro, già dal 2014 i meeting WEF a Davos promuovevano con insistenza il Great Reset, rivoluzione socio-economica a loro dire resa inevitabile dall’avvento di nuove tecnologie tra cui Intelligenza Artificiale, robotica, 5G e Blockchain. E nel 2010 la Rockefeller Foundation aveva pubblicato Scenarios for the Future of Technology and International Development, in cui si vaticinava, insieme alla quarta rivoluzione industriale, un’imminente pandemia che avrebbe spedito all’altro mondo 8 milioni di persone. Invece, cos’è successo?
Nel gennaio 2020 arrivarono sui nostri schermi immagini sconvolgenti di cinesi che “cadevano come birilli” per mano di un virus fulminante – situazioni da cinematografia fantascientifica mai più verificatesi in nessun’altra parte del mondo. Tant’è che in Cina il lockdown fu circoscritto a Wuhan e alla provincia di Hubei, di cui è capitale. La Cina, insomma, attivò e quasi subito disattivò l’emergenza. Dopo soli due mesi, quando Virus con un balzo prodigioso era sbarcato nel nord Italia, Wuhan tornò alla normalità.
Per comprendere il ruolo della pandemia nell’accelerare la transumanza verso il Nuovo Medioevo sarebbe utile rileggere Jean Baudrillard, il filosofo che meglio di tutti ha capito che nell’epoca del digitale la realtà finisce per sovrapporsi alla sua simulazione, divenendo così iper-reale, e in quanto tale incontestabile. Non c’è dubbio che la crisi sanitaria, vera in quanto simulata, sia dell’ordine dell’iper-realtà, proprio perché ci appare come un dogma inconfutabile: gli scettici e i dubbiosi sono eretici, e come tale vanno bruciati sul rogo. Altrimenti detto: abbiamo interiorizzato la nostra dominazione al punto tale da non poterla più riconoscere.
È lecito supporre che la maggior parte delle élites politiche fossero state informate sulla necessità di questa operazione. Ciò spiegherebbe perché tutti i capi di governo direttamente coinvolti, da tempo ridotti al ruolo di camerieri dell’alta finanza, abbiano recitato esattamente lo stesso copione. Il lancio di Virus gli dev’essere stato presentato come opzione molto meno traumatica rispetto a uno tsunami finanziario capace di mettere in ginocchio le maggiori economie occidentali, con annessi scenari da guerra civile. D’altronde, la stabilità finanziaria è nell’interesse di tutte le grandi potenze, incluse Cina e Russia, che per questo si suppone abbiano accettato di stare al gioco, anche se defilandosi quasi subito. Sicuramente più convinta la complicità degli alleati più fedeli degli Stati Uniti – sia quelli inseriti nell’alleanza dei ‘5-eyes’ (Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda) che quelli de facto sotto egemonia economica e militare americana, tra cui il ‘laboratorio Italia’.
Indipendentemente da quest’ultima ipotesi, puramente speculativa, riflettere sulla causa finanziaria sollecita una considerazione di natura socio-ontologica. Per comprendere la portata di ciò che stiamo vivendo dobbiamo allargare lo sguardo sull’intera struttura di riproduzione sociale. Ci sarà allora impossibile ignorare come l’emergenza covidiana sia sintomo di implosione sistemica: siamo entrati in una nuova fase storica caratterizzata dalla bancarotta del modo di produzione fondato sulla dialettica lavoro-capitale. Il blocco dell’economia ci ha detto che il lavoro salariato non è più la base della produzione di ricchezza nelle società capitalistiche. Questo perché il capitalismo può ormai solo affidarsi ai salti mortali della finanza, che, oltre a essere cinica e bara, è sempre più incompatibile con la struttura liberal-democratica di società fondate sul lavoro. Alla base del cambiamento di rotta verso il dominio totalitario del ‘capitale fittizio’ (Marx) c’è il crollo di redditività del capitale investito nell’economia reale.
Depurare il capitalismo dalla sua escrescenza finanziaria è dunque una pia illusione, per il semplice motivo che l’ingranaggio che muove le criminali speculazioni finanziarie è lo stesso che da sempre muove la ricerca del profitto. Parafrasando la formula di Marx nei Lineamenti, diremmo che l’anatomia della finanza è la chiave per comprendere l’anatomia del capitalismo sfruttatore di lavoro. Il capitale, indipendentemente da come si manifesta, è sempre denaro che crea altro denaro. E se fino a ieri lo sfruttamento del lavoro è stato il mezzo ideale per generare plusvalore e profitto, oggi, all’epoca dell’automazione e dell’intelligenza artificiale, il capitale a trazione tecnologico-finanziaria tende a liberarsi del lavoro salariato. Ma non possiamo illuderci che, con la fine della società del lavoro, il capitalismo crolli. Piuttosto, come ha sempre fatto, si auto-rivoluziona, inaugurando ora una nuova fase che ha tutti i crismi di un ritorno alle origini, cioè a un regime leviatanico di predazione diretta. Questa fase richiede nuovi strumenti critici e nuove logiche di opposizione.
Diciamolo più chiaramente: per sopravvivere all’attuale implosione sistemica, il capitalismo deve distruggere la sovrastruttura liberale e promuovere un regime subdolamente oligarchico. Dovrebbe essere chiaro che ci stanno confezionando addosso un capitalismo basato sul signoraggio monetario, a scapito di un’umanità ridotta a 1) Un immensa mandria di sottoccupati in condizioni neo-schiavistiche (i cui pionieri sono gli operatori di Amazon costretti a orinare in bottiglie e defecare in sacchetti di plastica); 2) Disoccupati a sussidio; 2) Masse di reietti di cui nessuno ha più interesse a occuparsi. Anche per questo le teorie di Malthus sul depopolamento rimangono attuali.
Questa deriva non sarebbe possibile senza il potenziamento della propaganda: i media oggi operano come il clero in epoca medievale. L’evoluzione stessa del sistema-mondo ha reso possibile la messa in atto del più grande progetto propagandistico di tutti i tempi. Le possibilità di manipolazione sono aumentate vertiginosamente con la diffusione capillare di nuove tecnologie, che entrano direttamente nelle menti dei più giovani. La materia prima, peraltro, è sempre la stessa: l’intima e irrefrenabile vocazione al conformismo della specie umana.
Jacques Lacan sosteneva che la più grande passione dell’essere senziente è l’ignoranza. Nulla è più irresistibile della nostra volontà di non sapere, di spegnere il cervello dinanzi all’ipotesi che la realtà possa essere diversa rispetto a come ci viene narrata. L’adattamento, fatto di tanti piccoli comportamenti ostinatamente meccanici, è da sempre l’opzione esistenziale prediletta di Homo sapiens, per il semplice motivo che il pensiero critico richiede uno sforzo piuttosto doloroso, che costringe alla solitudine. Molto più semplice unirsi al coro, specie quando fondato sul ricatto morale di una guerra sanitaria per la difesa dell’umanità. A quel punto diventa persino gratificante obbedire a moralizzatori imbellettati che si auto-proclamano salvatori del mondo, pur essendo gli stessi che da tempo lo devastano.
Il Covid è una forma di dominio reale fondata su un preciso linguaggio, un arsenale di armi semantiche usate con cinismo su popolazioni preparate da decenni a vivere nell’insicurezza e nel conformismo. Il successo di questo linguaggio si misura sulla capacità di installare una vera e propria liturgia covidiana, un culto fatto di nuove abitudini che ci accomunano solo nell’alienarci, nell’allontanarci ulteriormente da noi stessi e l’uno dall’altro: dalla mascherina al distanziamento, dal coprifuoco ai vaccini, dal ‘green pass’ alla sanificazione compulsiva delle mani. “Inginocchiati e prega, e la fede verrà da sola” – il vecchio monito di Blaise Pascal oggi potrebbe tradursi così: “metti la mascherina e mantieniti a distanza dal tuo prossimo, e la fede (nel Covid) verrà da sola.”
La vera malattia è la nostra assuefazione alla farsa globale. Storicamente, essa è frutto di un’affabulazione emergenziale cresciuta di intensità a partire dall’11 settembre 2001, data d’inizio di una ‘guerra globale al terrore’ che ha sterminato milioni di innocenti. La paura di un nemico esterno caricaturizzato all’inverosimile (da Bin Laden alle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein) rende il gregge particolarmente docile e pronto al sacrificio di tutto ciò che rende ancora vivibile la vita, poiché l’alternativa viene sempre dipinta come qualcosa di mostruoso, al limite dell’immaginazione, come appunto la ‘spaventosa morte da Covid’. La guerra epidemiologica, indipendentemente da dove e come sia partita, è oggi una guerra psicologica totale, surrogato dell’improbabile conflitto militare globale. Non illudiamoci, l’assedio è destinato a durare. La concessione di qualche ora di libertà vigilata servirà a indorare la pillola di nuove forme di coercizione.
Il destino del modo di produzione su cui si reggono le nostre società è l’implosione. Non se ne esce. La crisi da coronavirus conferma che il capitale dipende sempre più dal debito pubblico, dunque dalla creazione di denaro virtuale delle banche centrali, che finisce per svilire la moneta fiat (le valute nazionali per come le conosciamo dal 1971, quando fu interrotta la convertibilità dell’oro in dollaro). L’arrivo di una devastante iperinflazione legittimerà il consolidamento di valute digitali controllate dall’alto. Probabilmente si tratterà di un evento a tappe che il capitalismo potrà affrontare solo cavalcando nuove iterazioni di autoritarismo mascherato da una qualche ragione etica e umanitaria. L’unica reale alternativa al signoraggio monetario sarà abbattere definitivamente il sistema di produzione di merci a scopo di lucro, ma per far questo occorrerà una convergenza popolare tra tutti coloro che avranno compreso che il senso delle loro vite non è più gestibile dal capitalismo.
Note
1 A maggio 2021, il sistema di segnalazione passiva VAERS, che registra solo una piccolissima parte degli eventi reali, ha contabilizzato un numero di decessi dopo vaccinazione Covid negli USA superiore ai decessi per tutti i vaccini riscontrati nei precedenti 21 anni messi assieme.
Tradotto con http://www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)
Dal materialismo storico all’immaterialismo post-umano: il nuovo orizzonte della sinistra
L’identità di genere prende il posto dell’anima e diventa il nuovo oppio dei popoli, distribuito a piene mani dal progressismo che si mette al servizio delle multinazionali globali del transumano. Evviva il dirittismo e la libertà!

Sarebbe interessante se uno storico -meglio ancora una storica- si applicasse a ricercare e ad analizzare le ragioni per le quali dal materialismo storico, criterio di interpretazione di tutto ciò che è reale, la sinistra sia passata a un vero e proprio immaterialismo post-umano, chiave di un’ossessiva politica dei diritti basati su “percepiti” invisibili e cangianti, surrogati di quell’anima la cui negazione ha strutturato ogni forma di socialismo reale.
Il nuovo oppio dei popoli è l’identità di genere, madre di tutti i percepiti, sedativo distribuito a piene mani dalle formazioni progressiste dell’Occidente, da Joe Biden a Enrico Letta. Questione che probabilmente sarà di scarso interesse per le-i più giovani libere-i da questo fardello, ma che sta travolgendo il femminismo cosiddetto storico, da sempre in relazione efficace e tempestosa con la sinistra. Non aver trovato alcun piano di interlocuzione, tenacemente perseguito, con le sinistre promotrici dei vari Equality Act, Ley Trans o Ddl Zan che dir si voglia -la stessa pappa dappertutto- è stata la doccia fredda definitiva, destinata a produrre rilevanti conseguenze politiche.
Dal 1989 -ma anche da prima- la sinistra si è trovata ad affrontare il non irrilevante problema di dover riprofilare il proprio orizzonte, definitivamente sgomberato dai Palazzi d’Inverno e da ogni prospettiva rivoluzionaria. Ma nessuno avrebbe potuto immaginare che l’esito sarebbe stato questo, che dalle masse si sarebbe passati all’individuo atomizzato, dalla rivoluzione del popolo alla rivolta del singolo contro la sua stessa carne, gabbia oppressiva per quel multicolor succedaneo dell’anima a cui è stato dato il nome di identità di genere.
Per liberare questa animula, il corpo deve essere negato e preferibilmente torturato fino dalla più tenera età. Una sorta di cilicio simbolico. E il valore della relazione, da sempre baricentro dell’umanesimo a radice femminile, viene minimizzato a vantaggio di quell’individuo post-umano slegato da tutto, perfino dalla propria sostanza materiale, soggetto perfetto per ogni possibile mercato globale.
Resta da comprendere, ma qui ci vorrebbe davvero uno storico, per quale ragione oggi la sinistra si sia data il compito di rappresentare le ragioni e soprattutto i bilanci e i dividendi delle multinazionali globali del post e trans-umano- si potrebbe forse chiamare post-mercato o trans-mercato– che fanno profitti sull’annientamento delle relazioni, sulla mortificazione della carne umana, sul definitivo controllo di sessualità e riproduzione.
Ma lo sanno, quello che fanno?
Avanti o singolo, alla riscossa! Evviva il dirittismo e la libertà!
Marina Terragni
FONTE: https://feministpost.it/magazine/primo-piano/dal-materialismo-storico-allimmaterialismo-post-umano-il-nuovo-orizzonte-della-sinistra/
ARTE MUSICA TEATRO CINEMA
ATTUALITÀ SOCIETÀ COSTUME
Da l’approssimazione approssimativa al percorso di transizione
E intanto si disquisisce di vaccini, scuola temendola ancora in DAD, bullismo, DDL Zan e LGBT

Un anno mezzo fa, ormai, siamo stati sommersi da ondate che mai avremmo osato nemmeno pensare.
Saltiamo a pieppari i mesi che ci hanno visto come sappiamo. Arriviamo ad oggi. Che cosa è cambiato? Nulla.
Anche se questo governo doveva essere il salvatore della patria accompagnato dalla panacea i tutti i mali, ovvero, il vaccino, brancola ancora nel buio. O, meglio, nell’approssimazione. Sempre più approssimativa.
Abbiamo assistito a diatribe invereconde e inverosimili, a discussioni infinite da far perdere la pazienza anche a madre Teresa e a Ghandi.
Eppur abbiamo superato. O, meglio, pensavamo di averlo fatto.
Ricordiamo tutti quando a ottobre scorso, dopo l’apertura delle scuole, i banchi a rotelle erano stati scelti e pagati a palate di palanche. Dovevano essere la soluzione. Ma non lo furono.
Che fine hanno fatto non è dato sapere. Nonostante Azzolina sgonnelli tuttora, che altro sembra non fare, nei vari talk come se nulla “avesse stato”. Da piccola fiammiferaia con infanzia difficile e povera, superata con il suo QI superiore. Questo ci narra ogniqualvolta ne ha l’occasione. E continua imperterrita a difendere il suo fantolino. Oggi ci ritroviamo a dissertare sulle medesime cose. E a luglio si pensa, già con orrore, a quando si riapriranno le scuole. Ancora. Nonostante quasi la metà del popolo abbia ricevuto la sua prima dose. Ma che cosa succederebbe se un alunno dovesse risultare positivo. Lui a casa? Tutti a casa? Quanti a casa? In DAD, naturalmente. Al pensiero dell’acronimo suddetto, agli insegnanti ai presidi e ai ragazzi viene la pelle d’oca.
“Ma lo scorso ottobre non avevamo i vaccini” osa dire qualcuno. E un altro, della parte avversa.. “ma i vaccinati sono untori!” E digrigna i denti trattenendosi a stento dall’aggredirlo fisicamente, oltre che verbalmente.
E poi i medici e sanitari che non ne vogliono sapere, di vaccinare se stessi e i propri pazienti, mandando in tilt chi non sa più di chi fidarsi.
Per non dire dei novax e nivax. Quelli reali, quelli che lo ammettono.
No, francamente tutto questo è troppo. Non si può non avere il coraggio di decidere quello che la comunità scientifica ritiene giusto e opportuno. In nome di una libertà che amiamo tutti ma a cui in certi casi occorre rinunciare. Intanto la variante delta getta nel caos l’Europa che rimane senza una strategia comune. Tutti in bilico fra gestione del rischio e chiusure.
Qualcuno sostiene che l’obbligo vaccinale per alcune categorie speciali è incostituzionale. Come se il suo cibo quotidiano fosse pane e articoli costituzionali. Ma a chi ci dobbiamo rivolgere se non ai maggiori costituzionalisti?
Cassese, Zagrebelsky sostengono che l’obbligo non è incostituzionale
Celotto: “Green pass è costituzionalmente corretto, non discriminatorio” e afferma che per la prima volta un DPCM apre e non chiude.
Flick: «Serve una legge, non basta un decreto o un Dpcm»
Consulta: “Obbligo di vaccinarsi? Non è incostituzionale”
Il neo presidente della Consulta Giancarlo Coraggio : “Io mi vaccinerò. È un obbligo morale”, “Sì alle limitazioni della libertà per tutelare la salute”.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Intanto si viene a sapere che un ragazzo di diciotto anni, Orlando, si suicida , vittima di bullismo perché gay. Ma poi la notizia viene smentita quando si sente di un giro di prostituzione minorile. E che dire di un ragazzino di 16 anni, Manuel Raùl, sordo dalla nascita, asso e promessa del calcio. Anche lui sarebbe vittima di bullismo fin dalle elementari. Forse per invidia? Forse perchè troppo bravo pur avendo un handicap importante? Se cosi fosse c’è da chiedersi come abbiamo educato figli e nipoti e come siamo caduti così in basso. Dove abbiamo sbagliato.
Ma io mi rifiuto di crederci.
E si ritorna al problema scuola che, a tutti i costi, deve essere fra le priorità. Nella ripresa umana e sociale di questo martoriato Paese.
Certamente deve essere affrontato prima di un tema che interessa a una minoranza che non sempre è detto sia giusto tutelare. Se una minoranza di persone si droga o beve deve essere per caso essere più tutelata di altri?
Lungi da me considerare i transgender a livello di drogati e avvinazzati. Sono, altresì, persone, proprio come tutte le altre. Buone o cattive, virtuose o viziose, proprio come possono esserlo tutti. Ci tengono tanto, giustamente, ad essere liberi di fare le proprie scelte. Perchè negarglielo?
Esistono le leggi e, poi, la magistratura che deve dire la sua. Ci piaccia o meno.
Ma, poi, si sentono (video) esternazioni come queste:
“Bisogna aiutare i bambini in un loro percorso di transizione perché si ritrovano con un genere che non corrisponde al loro sesso di nascita”.
Sì, il signor Didielle Zan® ha proprio detto bambini.
Cioè, non ha detto che è sbagliato forzare i bambini ad avere atteggiamenti coerenti con il proprio sesso biologico, ha proprio detto “accompagnarli nel PERCORSO DI TRANSIZIONE”.
Non so cosa pensare.
In breve. Riflettiamo sul DIDIELLEZAN con calma. E poi votiamo. Aggia’ ma purtroppo non tocca a noi
PERCORSO DI TRANSIZIONE! Parola di Zan.
Semplicemente pazzesco. Ma come si fa a non rendersene conto. L’equilibrio mentale che dà di balta.
Ecco come si distrugge l’innocenza dell’infanzia come sostiene una cara amica.
Qualcuno avrà pur sentito parlare anche di gender fluid. No al DDLZAN. IN OGNI VERSIONE.
Perché DA COSA NASCE COSA.
Con tutto il rispetto e l’affetto di chi sceglie generi alternativi di costume e di abitudini. Devo in coscienza dire che il gender fluid è ben altra cosa. Nessuna identità binaria? A volte un ragazzo a volte una ragazza. Dipende da come ci si sente al momento.
E dovremmo far educare i piccoli da questa persone?
Usare la povera Raffa come icona dei transgender per sostenere il DDLZAN è abominevole e sconcertante.
Ricolfi, sociologo progressista, esordisce affermando che “La comunità LGBT vuole imporre a tutti la propria specifica e minoritaria visione del mondo:un atto di pura prepotenza cuturale.” Ecco il termine giusto per identificarli: prepotenza. Non solo culturale ma anche caratteriale dato che alcuni, non tutti per carità, sono così convinti di essere dalla parte giusta che si offendono e si inalberano se qualcuno li contraddice. E pretendono di essere considerati dalla parte giusta dal resto del mondo.
Secondo alcuni la propaganda LGBT dovrebbe cominciare in culla. E chi non è d’accordo è un omofobo. Ma anche basta!
Carla Ceretelli
FONTE: https://www.pensalibero.it/da-lapprossimazione-approssimativa-al-percorso-di-transizione/
BELPAESE DA SALVARE
Le sette Rome nella mappa del disagio
Nascere in un quartiere o in un altro determina la riuscita sociale a Roma. Nella mappa delle diseguaglianze del libro Monni-Tomassi e Lelo sono sette le città censite. Tutte avrebbero bisogno di politiche attive. E tutte andranno al voto in autunno.
Quando a Roma si parla di Roma è impossibile non cadere nella costernazione per una classe dirigente – politica, amministrativa, imprenditoriale – che non riesce a far funzionare le cose essenziali, a cominciare dal trasporto pubblico e dalla raccolta dei rifiuti. Sebbene sia da comprendere la sollecitazione della sindaca Virginia Raggi a non dimenticare le 459 cose fatte dalla sua amministrazione nei cinque anni 2016-2021 (https://www.cosefatte.it/), sarebbe più corroborante per il cittadino romano disporre, e vedere all’opera, una convincente “idea di città” che lo possa confortare sui suoi futuri standard di vita.
Non si può dire che sia una questione semplice, come non lo è per tutte le grandi metropoli. I retaggi storici, le responsabilità politiche, i processi sociali dai quali proviene il presente di questa città possono spiegare perché le discussioni in merito sono tanto intense quanto discordanti per punti di vista e per prospettive di sviluppo (a titolo indicativo https://sbilanciamoci.info/roma-la-capitale-vuota/). Cosa si potrebbe/dovrebbe fare per affrontare la complessità della questione – tema cruciale per dare senso alle alternative del prossimo confronto elettorale – deve partire dalla constatazione della radicata disomogeneità economica e sociale che si registra all’interno dell’area chiamata Roma.
Già nel 2019 Salvatore Monni, professore di Economia all’Università di Roma Tre, assieme a Federico Tomassi e Keti Lelo, hanno offerto una rappresentazione di tale questione nel libro La Mappa delle Diseguaglianze (con la postfazione Il caleidoscopio romano di Walter Tocci, Donzelli editore) per far toccare con mano la distribuzione sul territorio dei più indicativi fenomeni economici e sociali. Con l’utilizzo di eloquenti mappe vengono rappresentate le condizioni di reddito segnalando come i livelli di disoccupazione e il deterioramento della qualità dell’occupazione si accentuano via via che ci si allontana dal centro verso est e verso il litorale, cioè verso realtà la cui maggiore densità e più rapida crescita della popolazione non è indipendente dai maggiori costi della vita al centro della città.
Tendenze analoghe si ricavano dalle mappe relative al disagio economico e sociale (il mancato completamento del secondo ciclo di istruzione, la presenza di Neet, la densità di famiglie in difficoltà economiche e sociali). Le stesse condizioni del traffico e financo le differenze di genere su istruzione e lavoro, pur con qualche piccola eccezione e comunque con differenze interne, riflettono la tendenza generale. L’importanza dell’indagine, e delle rappresentazioni vivide che offre non risiede solo nel dar conto delle condizioni di vita fortemente differenziate all’interno della città, ma anche nel sottolineare il progressivo peggioramento delle periferie rispetto al centro della città che, sebbene sia comune a tutte le zone metropolitane del paese, risulta molto più accentuato rispetto alle tendenze presenti a Milano e a Torino.
È senso comune che dappertutto situazioni di disuguaglianza di partenza determinano possibilità di vita e di futuro ben diverse. Per la realtà romana lo illustra efficacemente la mappa relativa all’indice ISU (che considera congiuntamente livelli di reddito, condizioni sanitarie e competenze educative) i cui valori per le zone privilegiate sono più del doppio rispetto a quelle più disagiate: «Oggi a Roma nascere in un quartiere piuttosto che un altro significa avere più o meno opportunità di realizzare se stessi» (Monni all’Audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dell’8 aprile 2021, evento | WebTV (camera.it)). Una considerazione che non sembra provocare reazioni a livello istituzionale, ma i cui riflessi politici, se li si vogliono comprendere, sono attestati mirabilmente dalle mappe sui test elettorali dal 2016 al 2018.
La tendenza delle disuguaglianze a inasprirsi allontanandosi dal centro assumono forme variegate, considerato che i diversi aspetti che le caratterizzano hanno un diverso peso nelle varie zone di Roma. È questa osservazione che ha indotto il gruppo Lelo, Monni e Tommasi a fare un passo ulteriore per fornire una rappresentazione più fine, e una interpretazione più stimolante, della situazione cittadina. La loro proposta è che non si può parlare di “una” Roma, ma che di fatto ne esistono molte di più, e ne individuano almeno “sette”. E ne forniscono le immagini, le mappe, nel loro libro appena apparso in libreria, Le sette Rome. La capitale delle disuguaglianze raccontata in 29 mappe (Donzelli editore, 2021).
Le “sette Rome” (che parafrasano i famosi sette colli su cui è sorta Roma) è il tentativo degli autori di mettere ordine a quel “tessuto urbano fortemente disomogeneo dal punto di vista demografico, sociale ed economico” che è “l’attuale complesso mosaico della città che, nei 150 anni dopo Porta Pia, è cresciuta dieci volte nell’estensione fisica e quindici volte nella dimensione demografica”; a quella “grande area metropolitana che si estende dal mare fino ai primi rilievi appenninici. Sono sette immagini di realtà urbane differenti tra loro – individuate sulla base dei dati demografici e delle effettive dinamiche urbanistiche, sociali ed economiche – che possono essere considerate come “città” distinte, «perché ognuna di esse, pur non essendo delimitata da un punto di vista amministrativo, è perfettamente riconoscibile nelle proprie peculiarità e problematiche, nelle memorie e nei cliché che la riguardano».
Sulla base dei dati provenienti da fonti diverse (l’anagrafe di Roma Capitale, i censimenti Istat, i risultati elettorali per sezione, i valori immobiliari dell’Agenzia delle entrate, i dati comunali sulle fermate del trasporto pubblico e sugli incidenti stradali, un’indagine della Provincia di Roma sulla dotazione di servizi pubblici e privati, gli indirizzi delle case popolari, dati riportati nel loro blog www.mapparoma.info/open-data) gli autori hanno individuato le caratteristiche sociali ed economiche (composizione dei nuclei familiari, livelli di istruzione, tipologie occupazionali, dotazioni urbane, preferenze politiche) che contrassegnano in maniera significativamente diversa i differenti quartieri, spesso anche limitrofi.
Più precisamente, sono state identificate sei città su base territoriale: la città storica, colma di testimonianze artistiche, architettoniche e archeologiche; la città ricca, dei quartieri benestanti di Roma nord, dei villini dell’Eur, delle grandi ville dell’Appia Antica e della gated community di Olgiata; la città compatta, dei quartieri residenziali intensivi costruiti negli anni dell’espansione post-bellica; la città del disagio, la gran parte delle case popolari e delle borgate nate in maniera abusiva; la città dell’automobile, disposta lungo i principali assi di viabilità di scorrimento veloce (Gra, via del Mare, autostrada Roma-Fiumicino); la città-campagna, che comprende tutto ciò che resta dell’Agro romano. La settima è invece una città diffusa, la città degli invisibili, di quelle «migliaia di persone che sopravvivono, ai margini della società, su marciapiedi e angoli di strada, in centri per migranti, campi rom, carceri sovraffollate, abitazioni occupate o sgretolanti case popolari».
Gli aggettivi utilizzati per qualificare le sette città parlano da soli e suggeriscono realtà radicalmente diverse la cui storia e collocazione di classe condizionano la vita e il futuro degli abitanti di ciascuna area. Particolarmente significativa, e meritoria, è la rappresentazione della «vera e propria geografia del disagio socio-economico della città» (per inciso, da essa Andrea Mancori, Giorgia Amato, Cécile Berranger e Sara Vicari del collettivo aroundtheworld.coop, hanno tratto spunto per il loro documentario La città del disagio, che ha vinto il primo premio come “miglior documentario per la categoria giustizia sociale” al Just Film Festival di Birmingham (
Al riguardo merita soffermarsi sull’analisi, nella terza parte del libro, dell’impatto che la pandemia ha avuto sulle “sette Rome” appunto perché questo shock ne ha accentuato le specifiche disuguaglianze socio-economiche e culturali: le mappe di Lelo, Monni e Tommasi sono un formidabile sostegno alla tesi (di Richard Horton, di «The Lancet») che l’emergenza sanitaria dovuta al Covid debba essere considerata come una “sindemia” poiché i suoi effetti non si distribuiscono su tutti con la stessa intensità, ma colpiscono «soprattutto i più vulnerabili – precari, giovani, donne, stranieri – nonchè il ceto medio».
Ma il contributo del libro va al di là della pur encomiabile conoscenza più approfondita delle realtà di Roma, e del piacere di “vederle” attraverso l’eloquenza delle mappe. La sua maggiore importanza risiede nel porre in tutta la sua complessità la questione di quali politiche possono essere implementate per migliorare la qualità della vita dei romani. In presenza di “sette Rome” – diverse per condizioni di ricchezza, salute, istruzione, occupazione, attività economiche e qualità della vita – non è pensabile che il governo della città si possa esercitare attraverso “una”, unica e accentrata, politica produttiva, finanziaria, amministrativa con il rischio che privilegiare gli interessi di una “città” imponga, nel contempo, intralciare le aspettative di sviluppo di un’altra o più “città”.
Un’altra difficoltà emerge quando si consideri la non stretta corrispondenza tra il territorio delle sette città di Roma e quello delle circoscrizioni dell’attuale struttura amministrativa. Una discrepanza che rende inefficace qualsiasi forma di decentramento volto a semplificare l’azione di governo della città poiché, come al centro, anche ogni zona amministrativa rischia di dover fronteggiare realtà disomogenee, dal punto di vista economico e sociale, delle diverse sette città di Roma che si intersecano sul suo territorio. Tuttavia l’obiettivo dichiarato di Keti, Monni e Tommasi è quello di fornire gli strumenti per stimolare la riflessione su come affrontare le disuguaglianze che caratterizzano e penalizzano la crescita di Roma al fine di «definire politiche che consentano di migliorare la qualità della vita dei romani». Ebbene, si deve dire che l’obiettivo è raggiunto, ora si tratta di vedere quale discussione ne seguirà. Ma questo non dipende più dagli autori.
Keti Lelo, Salvatore Monni, Federico Tomassi, La Mappa delle Diseguaglianze, con la postfazione Il caleidoscopio romano di Walter Tocci, Roma: Donzelli editore, 1919.
Keti Lelo, Salvatore Monni, Federico Tomassi, Le sette Rome. La capitale delle disuguaglianze raccontata in 29 mappe (Donzelli editore, 2021), Roma: Donzelli editore, 1921.

Due donne di colore farmaciste

Nella pubblicità della ditta X, di cui non faccio il nome, apparsa sul Sole-24 ore del 15/7, vedonsi due donne di colore farmaciste.
L’immagine rispecchia in pieno quel che accade nel nostro Paese. Tutti sanno, infatti, che i barconi in arrivo dall’Africa sono strabocchevoli di donne farmaciste, ingegnere, architette, avvocatesse, mediche, chimiche, economiste, nonché di donne tout-court.
Nove e mezzo su dieci sono donne e nove e mezzo su dieci sono laureati e laureate nelle celebri Università africane, le più prestigiose del mondo.
FONTE: https://www.facebook.com/groups/105995086788673/permalink/844057856315722/
CONFLITTI GEOPOLITICI
Prima base interamente italiana nell’Africa occidentale.
Mai discussa in Parlamento
di Antonio Mazzeo*
L’Italia avrà il suo posto al sole nel deserto del Sahara. A margine dell’incontro con l’omologa francese Florence Parly, il 13 aprile a Roma il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha reso noto che nel quadro della missione bilaterale MISIN in Niger, le forze armate italiane realizzeranno una propria base militare “a partire dal mese di luglio”.
“Lo ritengo un passo molto importante per il rafforzamento della nostra azione nella regione, che in prospettiva andrà a confluire in una sempre maggiore capacità dell’Europa in Sahel e nell’intera fascia sub-sahariana, dal Corno d’Africa al Golfo di Guinea, mettendola a sistema con il contributo alla stabilizzazione della Libia”, ha dichiarato Guerini.
L’annuncio-scoop sulla prima base interamente italiana in Africa occidentale (mai discussa né approvata in Parlamento), giunge un mese dopo l’arrivo in Mali del primo contingente delle forze armate italiane da impiegare nella controversa missione internazionale “Takuba” in Sahel, sotto il comando dello stato maggiore di Parigi.
Una pericolosa escalation nella penetrazione militare in una delle aree più conflittuali del continente nero, in nome della lotta al terrorismo e al contrasto dei flussi migratori “illegali”, ma più probabilmente subalterna agli interessi economici delle transnazionali energetiche, francesi in testa, in una regione ricchissima di idrocarburi e uranio.
Partita in sordina dopo gli accordi stipulati il 26 settembre 2017 tra i ministeri della difesa di Italia e Niger, la missione MISIN fornisce assistenza militare alle forze di sicurezza nigerine per accrescerne le funzioni tecnico-logistiche ed operative.
“Il Governo ha autorizzato la Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger (con area geografica di intervento allargata anche a Mauritania, Nigeria e Benin) al fine di incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza, nell’ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell’area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine e dei Paesi del G5 Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger, NdA)”, spiega lo Stato maggiore della difesa.
Le attività di assistenza e formazione nella Repubblica africana da parte dei militari italiani sono indirizzate alle forze armate e alle task force “speciali”, alla Gendarmeria e alla Guardia nazionale. “Esse concorrono pure alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della componente aerea della Repubblica del Niger”, spiega ancora la Difesa italiana.
Rilevante il numero degli uomini e dei mezzi impiegati: secondo la legge di bilancio 2021, MISIN prevede infatti una presenza in Niger e presso il Defence College in Mauritania “fino a un massimo di 295 militari, 160 automezzi leggeri e pesanti e 5 aerei”.
Si tratta in particolare di team specializzati in operazioni di ricognizione, comando e controllo; personale per l’addestramento; team sanitari e del genio per lavori infrastrutturali; una squadra per le rilevazioni contro le minacce chimiche-biologiche-radiologiche-nucleari (CBRN); unità per la raccolta di informazioni d’intelligence e la sorveglianza.
Sino ad oggi quasi tutto il personale italiano è ospitato nella base aerea 101 realizzata e controllata dalle forze armate francesi accanto all’aeroporto internazionale “Diori Hamani” della capitale Niamey. Lo scalo è messo a disposizione pure delle unità aviotrasportate di US Africom, il comando statunitense per le operazioni nel continente africano.
I corsi addestrativi e di assistenza delle unità nigerine da parte italiana sono cresciuti progressivamente negli anni in quantità e qualità. In particolare al personale della Brigata “Folgore” sono attribuiti i compiti di formazione del neocostituito battaglione paracadutisti nigerino (programmi di fanteria di base, aviolanci, pianificazione e realizzazione completa di una operazione militare; pattugliamento motorizzato; organizzazione/gestione di check point e combattimento nei centri abitati).
Ancora i parà della Folgore hanno realizzato all’interno di un’installazione di Niamey un’area addestrativa “nella quale sono stati dislocati numerosi artifizi allo scopo di sviluppare le capacità di exploitation e sviluppo dei movimenti sul terreno dei militari nigerini”, come riporta il comunicato emesso dal Comando MISIN in occasione della sua inaugurazione, il 26 gennaio 2021.
Agli addestratori dell’Esercito e dell’Aeronautica militare sono affidati le attività di formazione e consulenza a favore del Groupe d’intervention spécial (GIS), il gruppo di intervento speciale del ministero degli interni nigerino, mentre a una task force del 7º Reggimento Carabinieri “Trentino-Alto Adige” (di stanza a Laives, Bolzano) è assegnato l’addestramento e il monitoring del nuovo reparto d’élite nigerino, il Groupes d’Action Rapides – Surveillance et Intervention au Sahel (GARSI) della Guardia nazionale, impiegato in funzioni di controllo dell’ordine pubblico e anti-terrorismo.
Oltre che in Niger, le unità di pronto intervento GARSI sono state istituite anche in altri paesi del Sahel (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Senegal) grazie ad un generoso contributo dell’Unione europea attraverso il Fondo d’emergenza per l’Africa (66 milioni e 600 mila euro).
Mentre la parte meramente addestrativa e di fornitura delle attrezzature militari è affidata alle forze armate dei paesi Ue presenti in Africa occidentale, la programmazione e la gestione del progetto GARSI è di competenza della Fundaciòn Internacional y para Iberoaméricana de Administraciòn y Polìticas Publicas, cioè la fondazione per la cooperazione allo sviluppo del governo spagnolo.
“Il compito istituzionale del GARSI è quello di prevenire e lottare contro il terrorismo internazionale, l’immigrazione illegale, la criminalità transazionale organizzata”, spiega la Commissione Ue. “Il programma contribuisce al rafforzamento delle capacità operative nazionali per assicurare un controllo effettivo del territorio e delle frontiere e lo stato di diritto in tutto il Sahel, grazie a unità di polizia robuste, flessibili, mobili, multidisciplinari e autosufficienti”.
Ancora una volta, replicando le narrazioni main stream delle cancellerie europee e d’oltreoceano, lotta al terrorismo, alla criminalità e al traffico di migranti sono gli obiettivi chiave e unitari del progetto GARSI, implementato dalle unità militari d’eccellenza e dalla moderna “cooperazione allo sviluppo” di casa Ue.
L’ambiguissimo modello di supporto e cooperazione CIMIC (cioè civile-militare) è stato assunto in proprio anche dal Comando operativo di MISIN. Sempre più spesso, infatti, le forze armate italiane sono impegnate nella contestuale consegna di “aiuti”, beni e materiali vari (dai sistemi d’arma ai farmaci, alle attrezzature sanitarie e finanche giocattoli e materiale scolastico e sportivo) alla controparte militare nigerina e alle autorità locali.
Lo scorso anno l’Aeronautica ha ceduto alle forze aeree nigerine “dotazioni” non meglio specificate per la “protezione e la difesa delle istallazioni e del proprio personale nei principali aeroporti attivi del Paese”. Materiale sanitario “a favore della popolazione nigerina” è stato consegnato alle forze armate di Niamey dalle unità del Policlinico Militare “Celio” di Roma e della Scuola di Sanità e Veterinaria Militare dell’Esercito in missione in Niger.
Sempre lo Stato maggiore della difesa fa sapere che lo scorso 25 marzo, il contingente MISIN ha concluso un altro progetto CIMIC “a favore del villaggio di Dara”. Nessun dubbio per i contribuenti italiani sulla sua rilevanza “civile”.
“Si è trattato della donazione di derrate alimentari e dispositivi sanitari che serviranno al personale paracadutista nigerino quale contingenza nel contrastare la pandemia da Sars-CoV2”, spiega la Difesa. “Il supporto alla popolazione è una delle attività MISIN che si affianca a quella principale di assistenza alle Forze di Difesa e Sicurezza, focus primario della missione che viene realizzato sia in maniera diretta, sia facilitando la distribuzione di aiuti umanitari provenienti dalla cooperazione internazionale del Ministero degli Affari esteri”.
Per saperne di più sulla missione italiana in Niger (MISIN):
https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/Niger_missione_bilaterale_supporto/Pagine/default.aspx
FONTE: https://sinistrainrete.info/articoli-brevi/20264-antonio-mazzeo-prima-base-interamente-italiana-nell-africa-occidentale-mai-discussa-in-parlamento.html
CULTURA
La metafisica del Caos e il Soggetto Radicale di Aleksandr Dugin (1a parte)

(P. Paolo M. Siano) Dopo l’articolo del Prof. Roberto de Mattei “George Soros e Alexander Dugin: due facce di una stessa medaglia?” (vedi qui), ho sentito l’esigenza di approfondire il caso Dugin anche perché alcuni intellettuali cattolici e amici di area tradizionalista guardano con entusiasmo al noto politologo e filosofo russo (vedi qui e qui) forse senza avere compreso i contenuti inquietanti del suo pensiero.
Come vedremo, nella sua essenza il pensiero duginiano non è affatto compatibile con la Fede Cattolica, a meno che non si sacrifichino i princìpi della logica umana e aristotelica, in particolare i princìpi di identità e di non-contraddizione. In effetti Dugin e i suoi discepoli ritengono necessario superare anche il logos e la logica aristotelica… Oltrepassando le certezze di Fede e Ragione, l’Uomo duginiano, o Soggetto Radicale, si sprofonda nella metafisica del Caos illudendosi così di giungere alla Luce, alla Nuova Era… Torneremo su questi punti, ma intanto il lettore può già intravedere tracce di mentalità gnostica e iniziatica…
Da alcuni anni il pensiero di Dugin è promosso e tradotto in Italia da AGA Editrice di Cusano Milanino (Milano) del Dr. Maurizio Murelli e anche da ambienti di Destra legati alla figura di Adriano Tilgher (vedi qui, qui, qui), in particolare il periodico on-line “Il Pensiero Forte” (vedi qui, qui, qui, qui, qui).
Nel giugno 2019 Dugin fa un tour in Italia, tiene ben 11 conferenze in 10 giorni, cominciando da Roma (vedi qui).
Anche Radio Radicale si è interessata a Dugin e ha postato il video del dibattito “Il Sole di Mezzanotte. Dall’Uomo differenziato al Soggetto Radicale” organizzato da AGA e registrato a Milano il 7 giugno 2019. Al dibattito: «Sono intervenuti: Maurizio Murelli (editore di AGA Editrice), Sergio Luppi (professore), Luca Siniscalco (professore), Andrea Scarabelli (vice segretario della Fondazione Julius Evola), Francesco Marotta (responsabile di GRECE in Italia), Aleksandr Dugin (politologo e filosofo)» (vedi qui).
Nel giugno 2018 viene postata su YouTube l’intervista di Lorenzo Centini, per “Il Pensiero Forte”, al Dr. Andrea Virga che è il curatore dell’edizione italiana del libro di Dugin “La Quarta teoria politica”. L’intervista postata è di soli 3 minuti e 17 secondi (qui). È logico pensare che l’opera curata dal Dr. Virga, molto stimato da “Il Pensiero Forte” (vedi qui), descriva oggettivamente e fedelmente vita e pensiero del filosofo russo.
Passiamo perciò al libro di Aleksandr Dugin “La Quarta Teoria Politica” a cura di Andrea Virga, trad. di Camilla Scarpa, NovaEuropa Edizioni, Milano 2017.
Evidenzierò in grassetto alcuni concetti e brani che ritengo importanti.
Nella premessa “Comprendere Dugin” (cf. pp. XV-LXXIV), Virga espone vita e pensiero del filosofo russo nato a Mosca il 7 gennaio 1962.
L’esoterista Julius Evola è «il principale maestro italiano di Dugin» (p. XV).
Aleksandr Dugin, figlio di un tenente generale del servizio d’intelligence militare sovietico (cf. p. XVII), da giovane mostra «tendenze anticonformiste» e un’«attrazione verso le idee più distanti e scioccanti rispetto all’ortodossia marxista e materialista: l’occultismo e il nazifascismo» (p. XVIII).
Intorno al 1980 il giovane Dugin comincia a frequentare il Circolo Juzinski fondato dallo scrittore Jurii Mamleev (che nel 1974 emigra dall’URSS), il cui successore, Evgenji Golovin, fonda la setta “Ordine Nero delle SS” (cf. p. XVIII). Virga afferma che «secondo numerose testimonianze», le attività del circolo di Mamleev e Golovin si basavano «sul rifiuto delle convenzioni sociali sovietiche e russe», «sull’uscita dalla normalità» per «raggiungere uno stato di coscienza superiore» (p. XVIII) attraverso «consumo massiccio di alcolici», «droghe», «sesso», la lettura di autori come Guénon «e la pratica di rituali occulti di ogni tipo» (cf. p. XIX).
In quell’ambiente Dugin entra in contatto «con gli autori perennialisti e rivoluzioniario-conservatori che avrebbero avuto un ruolo cruciale nello sviluppo del suo pensiero radicalmente postmoderno» (p. XIX). Dugin legge e traduce autori stranieri, come ad esempio Evola. Nel 1982 Dugin è arrestato dal KGB perché detiene «letteratura sovversiva», ma conseguenze più gravi gli sono evitate dall’intervento del padre (tenente generale del GRU) che poi è trasferito all’amministrazione doganale (cf. p. XIX).
Nel 1986 Dugin entra nell’associazione nazionalista “Pamjat” che secondo Aleksandr Jakovlev (ideologo di Gorbacëv) era sostenuta dal KGB che in tal modo: a) controllava una parte del dissenso, b) creava agenti provocatori, c) ed esplorava nuove possibilità politiche in vista del plausibile crollo del comunismo (cf. p. XX).
Secondo Virga le «principali coordinate» del pensiero di Dugin sono «tradizionalismo, fascismo, Rivoluzione Conservatrice, euroasiatismo» (p. XXXV), e «l’autore tradizionalista che ha esercitato su di lui il maggiore ascendente è Julius Evola (1898-1974)» (p. XXXVII). L’Uomo evoliano deve «“cavalcare la tigre” della modernità senza farsene travolgere, praticando una sorta di nichilismo attivo» (p. XXXVII).
Virga spiega che «nell’esoterismo occidentale», come già nella «filosofia indiana», si distinguono la “Via della Mano Destra” (confessionale, teista, religiosa) e la “Via della Mano Sinistra” che «rigetta l’ortodossia religiosa e i suoi precetti in favore di una concezione olistica, relativista e panenteistica della realtà, all’interno della quale l’Io […] persegue liberamente […] il proprio cammino di crescita verso l’autodivinizzazione» (p. XXXVIII).
Apro una parentesi per precisare che già Evola descrive, e fa sua, la Via della Mano Sinistra che è la via del Tantrismo, della trasgressione morale e sessuale, è la via del dio androgino Shiva che distrugge per ricreare… (cf. J. Evola, Metafisica del sesso, Edizioni Mediterranee, Roma 20094, pp. 132-138, 151-160, 300, 309).
Torniamo al testo del Dr. Virga il quale afferma: «La prospettiva della Via della Mano Sinistra era abbracciata da Golovin e dai suoi seguaci, incluso Dugin» (Virga, op.cit., p. XXXVIII).
Virga afferma che la prospettiva politica di Dugin «è palesemente di matrice evoliana, piuttosto che guénoniana, dato l’evidente primato dell’azione sulla contemplazione. Più nello specifico, però corrisponde alla scelta descritta nel succitato Cavalcare la tigre, ovvero alla cosiddetta Via della Mano Sinistra. Questa via è sottesa a tutto il suo agire politico. La stessa ideologia del PNB [Partito Nazional-Bolscevico], del resto, si fondava sull’abbraccio tra ideologie radicali e apparentemente contraddittorie, come il fascismo e il bolscevismo, col fine dichiarato di creare un fascismo “puro” russo» (p. XXXIX).
Virga cita un brano di Dugin e commenta: «“I tempi della fine e il significato escatologico della politica non si realizzeranno da soli […] Se la Prassi della Quarta Teoria Politica non è in grado di realizzare la fine dei tempi, allora sarebbe inutile”. È solo con la fine dell’Età Oscura che si può tornare all’Età dell’Oro. Tuttavia, contrariamente alla visione perennialista, per Dugin, questa Fine va perseguita attivamente, pena l’infinito prolungarsi del Tempo e della Storia» (pp. XXXIX-XL).
Virga prosegue: «Naturalmente, agli occhi dei tradizionalisti, sia guénoniani che confessionali, queste posizioni sono erronee e pericolose. Ad ogni modo, se è innegabile la presenza di importanti divergenze, d’altro canto è altrettanto indiscutibile che la sua concezione metafisica e metapolitica appartenga a questa Weltanschauung, al di là delle deviazioni. La stessa natura paradossale del suo pensiero corrisponde ad una vera e propria metafisica del Caos (da lui rivendicata), che appartiene alla tradizione dell’esoterismo della Mano Sinistra, e concorda con la Postmodernità, caratterizzata da pensiero debole e società liquida» (p. XL).
Anche sul versante religioso Dugin sa “unire” gli opposti : «[…] D’altro canto, le sue posizioni filosofiche contrastano con una sincera adesione religiosa, ma non impediscono di riconoscere il ruolo sociale e politico delle religioni organizzate, in linea con il cesaropapismo ortodosso. Questo spiega la sua opzione per l’ala moderata dei Vecchi Credenti, la quale consente di tenere insieme il tradizionalismo liturgico con la fedeltà politica al Patriarcato di Mosca. Allo stesso modo, la sua opposizione al cattolicesimo nello spazio eurasiatico convive con il dialogo coi conservatori cattolici in Europa. Tuttavia, anche a un’analisi superficiale è evidente l’incompatibilità tra l’ortodossia cristiana e la sua Weltanschauung» (p. LII).
L’«atlantismo» è un male per Dugin (cf. p. LIII). Egli si oppone anche a Israele e tale opposizione è «di tipo geopolitico» (p. LIII).
Nel paragrafo “Problematiche della filosofia di Dugin”, Virga scrive: «Non si può negare che Aleksandr Dugin sia un autore complesso e contraddittorio, a volte apparentemente folle, se si manca delle corrette chiavi di lettura. Tende ad adattare i propri discorsi a seconda del mezzo e dell’uditorio, al punto che non è sempre chiaro quanto certe semplificazioni, perfino grossolane (ad esempio, l’infatuazione per Trump), siano pronunciate solo a fini retorici o denotino un’effettiva superficialità nell’analisi» (p. LVI).
Nel paragrafo “L’idealismo gnostico di Dugin” Virga mostra che Dugin elogia la Via della Mano Sinistra: «La prima problematica concerne la visione metafisica di Dugin, che è essenzialmente gnostica, ossia persegue la salvezza del mondo materiale attraverso una conoscenza superiore e illuminata (gnosis), frutto di un percorso personale, elitario, in quanto svincolato da fedi e morali. Il filosofo russo ha, da tempo, proclamato la sua adesione allo gnosticismo, identificato con la Via della Mano Sinistra. Quest’ultima – a differenza della Via della Mano Destra, considerata alloppiante, falsa e incapacitante –, attraverso la sofferenza e le esperienze più radicali e terribili, porta alla conoscenza e alla liberazione autentica dalla materia: “Colui che segue la Via della Mano Sinistra sa che un giorno l’imprigionamento finirà. La prigione della sostanza collasserà, essendosi trasformata in una città celestiale. La catena degli iniziati prepara appassionatamente un momento desiderato, il momento della Fine, trionfo della liberazione totale”» (pp. LVI-LVII).
Circa «questa via» (della Mano Sinistra), Virga afferma che Dugin la ribadisce nel suo saggio Metafisica del Caos (cf. Virga, op. cit., p. LVII). Secondo Dugin il “logos” che è «cifra del pensiero occidentale», è in crisi, non bisogna restaurarlo ma trascenderlo appellandosi al «Caos pre-ontologico» (cf. pp. LVII-LVIII). Ecco il commento di Virga: «È una posizione perfettamente consona alla Via della Mano Sinistra, ma del tutto impolitica» (p. LVIII).
Tra «le conseguenze filosofiche dello gnosticismo duginiano», Virga segnala: «Escatologismo, sul piano storico, che implica una visione di tipo messianico-apocalittica, per cui la Storia si avvia necessariamente in direzione della Fine dei Tempi, al di là della quale però non si intravede né un Paradiso ultraterreno né un ritorno ciclico all’Età dell’Oro» (pp. LVIII-LIX). (continua)
FONTE: https://www.corrispondenzaromana.it/la-metafisica-del-caos-e-il-soggetto-radicale-di-aleksandr-dugin-1a-parte/
La Biblioteca come Labirinto. Anzi, come Deserto
gio 15 lug 2021
L’editoria, si sa, è affare per folli, per avventurieri, per dissipatori. L’autentico editore non vuole ‘vendere’ libri, affare vile – gli affari, poi, si fanno facendo altro, vendendo panini, aerei, l’anima, semmai – ma imporre una visione del mondo. L’Italia ha avuto alcuni grandi imprenditori dell’editoria e rarissimi editori. Uno di questi era Franco Maria Ricci, aristocratico, collezionista, amante della bellezza, costruttore di labirinti (quello di Fontanellato, che vale una visita). Ha pubblicato libri di imponderabile magnificenza; dal 1975, con Jorge Luis Borges, costruì “La Biblioteca di Babele”, che è forse – per avventatezza, inutilità, stupore – la collana editoriale più bella del mondo. La collana, partita con Le morti concentriche di Jack London, durò dieci anni passando per Giovanni Papini, Léon Bloy, La piramide di fuoco di Arthur Machen, Le mille e una notte, Henry James e Leopoldo Lugones. Naturalmente, fu imitatissima da editori-imprenditori che oggi passano per essere chic.
Il labirinto esiste in sé, come gioco, o perché al centro c’è il mostro? Se si riduce il labirinto a enigma, a tensione ludica, se ne disinnesca l’implicita ferocia. In un labirinto si deve poter morire: di stenti o per l’assalto improvviso – provvidenziale – della bestia. Un libro sui Labirinti (stampa Rizzoli) ne censisce, in modo spericolato, molti, in ogni angolo del globo: l’Italia ne ingloba parecchi – anche la facoltà retorica, il vizio politico è labirintico, l’uomo è questa serpe che s’attorciglia creando un grumo di vie senza esito. Due pagine sono dedicate al labirinto di Fontanellato, provincia di Parma, creato da Franco Maria Ricci, visitabile. “Il suo creatore, Franco Maria Ricci, editore di libri eleganti ed esclusivi, ha definito Masone ‘una città dentro un labirinto’ e i suoi ampi spazi includono anche una cappella a forma di piramide… Quando accennò a Jorge Luis Borges, di cui pubblicava le opere, la sua intenzione di realizzare il più grande labirinto del mondo, ebbe questa risposa: ‘A che scopo? Esiste già; si chiama deserto’”.
Nobile, indipendente, affascinante, Franco Maria Ricci ha creato i libri più belli – per lo meno, graficamente – dell’editoria italiana. E lo sapeva. Certo, occorre nutrire rispetto per un uomo che ha dedicato parte della vita a stampare, in vari volumi (“12 in facsimile per le tavole, 5 per i testi e uno di presentazione e studio con testi di Barthes, Venturi, Jacques Proust… e introdotto da Borges”), l’Encyclopédie di Diderot e D’Alambert (dal 1970 al 1980) e l’altra parte – dagli anni Novanta – a ideare e costruire un immane labirinto, in muraglie di bambù. Enciclopedia e labirinto: paiono concetti in contraddizione per chi ignora che, come l’enciclopedia, il labirinto è un tentativo di insaccare il caos, evocandolo.
“Com’è noto, quando fece costruire il suo Labirinto, che era una prigione, Minosse nutriva intenzioni cupe e crudeli; io immaginai un equivalente addolcito, che fosse anche un Giardino, dove la gente potesse passeggiare, smarrendosi di tanto in tanto, ma senza pericolo”. Qui non FMR, formidabile esteta, va fuori via: anche il Giardino è una prigione, tra Eden e Babele la distanza è tra la stazione eretta e l’andare a quattro zampe. Senza pericolo non c’è labirinto: è Minotauro la serratura del palazzo. Nel labirinto si entra da ciechi – decuplicando lo smarrimento – o con la spada, traducendo il mostro in trono.
Franco Maria Ricci è stato l’editore dei libri più belli – e introvabili – che ci siano. Come Scheiwiller consolidò un legame con Ezra Pound, così FMR si legò a Jorge Luis Borges. Intorno a lui – che ne fu il direttore – realizzò la collana “La Biblioteca di Babele”, magnifica, ideale biblioteca di libri senza tempo, a smangiare l’infinito, che costringono pure l’angelo alla caduta nell’alfabeto.
|
|
FONTE: https://www.lintellettualedissidente.it/
Gaspara Stampa. Signor, io so che ‘n me non son più viva
Un verso, la poesia su doppiozero
Un verso di Gaspara Stampa: dalle sue Rime, che furono in gran parte rime d’amore. I poeti del Cinquecento italiano, rimodulando e reinventando le rime di Petrarca, maestro d’amore, consegnarono ai lettori una meditazione sull’amore che toccò un arco estesissimo di temi e sperimentò un ventaglio amplissimo di registri espressivi: al punto che se volessimo oggi dire del desiderio, delle sue forme, delle sue radici, della sua lingua, basterebbe raccogliere da quei lontani versi figure e motivi, e avremmo un compiuto trattato appunto sul desiderio, sorprendentemente in dialogo con le odierne idee sul nesso tra desiderio e mancanza, e sulla fisicità e corporeità del desiderio.
Nella stessa epoca numerosi Trattati d’amore e Dialoghi sull’amore (quelli del Tasso, tra i primi) fecero da controcanto ragionativo e analitico alla poesia d’amore. Michelangelo Buonarroti e Gaspara Stampa furono tra i poeti che con più vigore immaginativo affidarono al verso un pensiero dell’amore annodato intorno all’idea di mancanza, di privazione, di vuoto, e con una tensione tutta fisica che allo stesso tempo dialogava, nella finitudine, con la vertigine dell’oltre, dell’impossibile, dell’estremo. Il contributo della poesia femminile in questa corale ricerca sulla condizione amorosa è grandissimo, e ricco di soluzioni formali e di invenzioni stilistiche: Isabella Del Morra, Tullia D’Aragona, Veronica Franco, Chiara Matraini, ciascuna con i propri modi, si fecero fini tessitrici di un pensiero rinascimentale dell’amore.
Dalla sponda francese il rapporto con Petrarca passò, oltre che da Ronsard e dagli altri poeti della “Pléiade”, da Louise Labé, la “belle cordière” di Lyon, che nei suoi versi accesi, gridati, e insieme dolcissimi, tessuti di fisico ardore, mandò in frantumi i residui artifici del petrarchismo di maniera.
Ma ecco la prima quartina del sonetto di Gaspara Stampa (Rime, CXXIV):
Signor, io so che ‘n me non son più viva,
e veggo omai ch’ancor in voi son morta,
e l’alma, ch’io vi diedi non sopporta
che stia più meco vostra voglia schiva.
I versi hanno, come accade in molte delle Rime, un movimento allocutorio, il cui destinatario, responsabile della ferita d’amore, lo si identifica con il conte Collaltino dei Collalto (di un “diario d’amore” hanno parlato alcuni a proposito di queste Rime dell’innamorata poetessa, partecipe della mondanità artistica e musicale veneziana, lei stessa suonatrice di liuto). Di fatto il motivo annunciato nei primi due versi – il morire d’amore – è come l’offerta tematica che Gaspara Stampa varierà via via, fino a comporre una riflessione sulla condizione amorosa intesa come esperienza dell’assenza. Certo, dalle dottrine medievali sull’amore fino alle riflessioni umanistiche il “morire d’amore” era stato osservato come perdita di sé, caduta nell’opacità di un’assenza di sé a sé, per via di un pensiero dominante che faceva deserto intorno al sentire; e in questa accezione lo stesso Comento di Marsilio Ficino al Simposio platonico, punto di irradiazione di una rinascimentale teorica dell’amore, aveva inteso quel “morire”: “è morto in sé qualunque ama: o egli vive almeno in altri”.
Di questo tema del “morire d’amore” – un tema che giungerà al Baudelaire di L’invitation au voyage (“aimer à loisir,/aimer et mourir”) – Gaspara Stampa definisce in altri versi la natura e il movimento (Rime, CC) :
perché in amor non è altro il morire,
per quel ch’a mille e mille prove ho scorto,
che aver poca speranza e gran disire.
Tuttavia per la poetessa veneziana il morire a sé è al contempo un morire nell’altro: il senso di una bianca solitudine si spalanca. Una sorta di desertificazione dei sensi. Uno spossessamento dell’io che un altro poeta d’amore, amato da Rilke (e da lui tradotto), Michelangelo Buonarroti, consegna a un domandare inquieto e rimedita come presenza che penetra e svuota, trafigge e si dissolve:
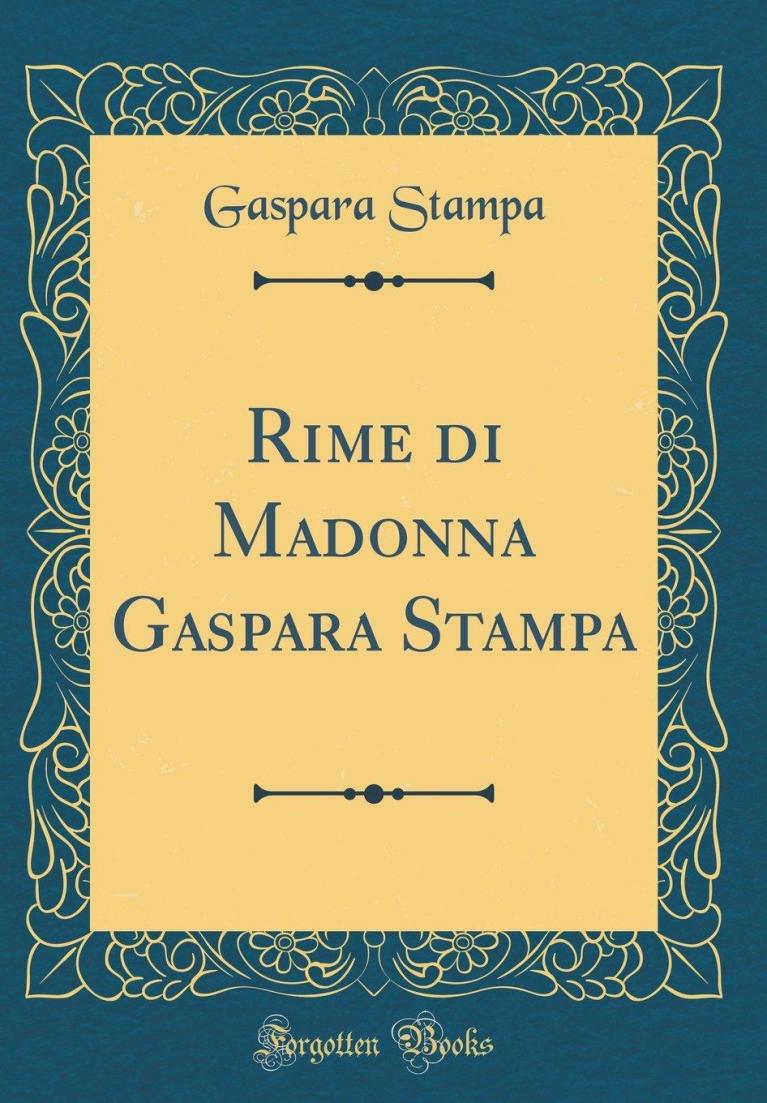
Come può esser ch’io non sia più mio?
O Dio, o Dio, o Dio,
chi m’ha tolto a me stesso,
c’a me fusse più presso
o più di me potessi che poss’io?
Gaspara Stampa conclude il citato sonetto sullo spossessamento di sé (“Signor, io so che ‘n me non son più viva”), rimodulando il tema del morire d’amore come riduzione dell’io a pura parvenza: spostamento del sé, della sua natura, in una forma divenuta evanescente, intangibile. Suono privo di parola, figura priva di sostanza:
sì che può dirsi la mia forma vera,
da chi ben mira a sì vario accidente,
un’imagine d’Eco e di Chimera.
Il Canzoniere della giovane poetessa percorre, sul contrappunto di una lontananza dell’altro, il repertorio del discorso amoroso in molte sue figure: l’attesa, la partenza, la distanza, il ritorno, la prigionia, la libertà dal vincolo. Figure, tutte, giocate da un significante che le ravviva e le consuma, le fissa e le svuota: la Sparizione. Una storia d’amore che si misura con i fantasmi e le spine dell’impossibile. Pianto, esaltazione, grido, confidenza, accusa, silenzio, rinuncia, spasimo sono l’alfabeto di una lingua che configura non la realtà di un amore, ma la sua irriducibilità al reale, il suo patto con l’incolmabilità e con il vuoto del desiderio. E un tema risalta lungo la tessitura musicale e pensosa dei versi: il corpo dell’altro immaginato come principio di crudeltà, una crudeltà motivata dal fatto che egli possiede, oltre al proprio cuore, il cuore dell’amante. Un tema, anche questo, antico, che aveva già avuto nella poesia provenzale una sua modulazione. Ecco come appariva in un verso della bellissima canzone di Bertrand de Ventadorn Can vei la lauzeta : “Tout m’a mo cor, e tout m’a me” (“Tolto m’ha il cuore, e tolto m’ha me stesso”). Ma per Gaspara Stampa il corpo dell’amante che possiede l’altro cuore è un corpo “mostruoso”. Come corpo “mostruoso”, infatti, lo si deve ritrarre (Rime, LV):
Fategli solamente doppio il core,
come vedrete ch’egli ha veramente
il suo e ‘l mio, che gli ha donato Amore.
E a questo motivo del cuore rubato da Amore e donato a un altro ecco aggiunte le immagini classiche dello “strazio” d’amore, tolte alla tradizione figurativa della caccia animale (Rime, CXLII):
Rimandatemi il cor, empio tiranno,
ch’a sì gran torto avete ed istraziate,
e di lui e di me quel proprio fate,
che le tigri e i leon di cerva fanno.
Se amore è questa esperienza di subìta crudeltà, di vuoto e di sparizione, luminosa appare allora la libertà dal vincolo e dalla prigionia, che coincide con il ritorno al giovanile possesso di sé, precedente alla caduta nella condizione amorosa (Rime, CCVII):
Poi che m’hai resa, Amor, la libertade,
mantienmi in questo dolce e lieto stato,
sì che ‘l mio cor sia mio, sì come è stato
ne la mia prima giovenil etade.
…
E tuttavia per il vero poeta d’amore, da Petrarca in poi – e così è per Gaspara Stampa, come per Louise Labè – si muore d’amore con un bel verso. Come dire l’amore è domanda più forte della stessa esperienza d’amore.
FONTE: https://www.doppiozero.com/rubriche/4177/202106/gaspara-stampa-signor-io-so-che-n-me-non-son-piu-viva
“LIBERI DI OBBEDIRE”
L’ultimo saggio di Johann Chapoutot, “Nazismo e management – Liberi di obbedire”, ci racconta come una determinata concezione dell’organizzazione sociale e del lavoro dominante oggi, basata sulla fine del conflitto tra capitale e lavoro, prenda piede e si diffonda durante il Terzo Reich.
CYBERWAR SPIONAGGIO INFORMAZIONE DISINFORMAZIONE
RESTANO I NOMI DEGLI SPIONI ITALIANI
 Fino a sei mesi fa i giornali pompavano la notizia del coinvolgimento di Leonardo nell’ipotesi di brogli elettorali in danno di Donald Trump. Oggi della spy story in salsa tricolore si parla sempre meno, e circa cinquecento riferimenti italiani del Deep State starebbero tirando un bel sospirone di sollievo a pieni polmoni. Ma la storia è davvero finita o Trump può ancora mollare un colpo ferale contro i suoi detrattori italici?
Fino a sei mesi fa i giornali pompavano la notizia del coinvolgimento di Leonardo nell’ipotesi di brogli elettorali in danno di Donald Trump. Oggi della spy story in salsa tricolore si parla sempre meno, e circa cinquecento riferimenti italiani del Deep State starebbero tirando un bel sospirone di sollievo a pieni polmoni. Ma la storia è davvero finita o Trump può ancora mollare un colpo ferale contro i suoi detrattori italici?
La vicenda della frode elettorale è stata metabolizzata dall’ex presidente Usa, che ora lavorerebbe alle prossime tornate elettorali: in mano agli avvocati di Trump rimangono le indagini e le prove ufficiali dell’Fbi in merito a circa cinquecento italiani importanti e convolti nello spionaggio a favore di multinazionali, banche d’affari, società informatiche, telefoniche e di security. L’Fbi ha tracciato l’ultradecennale vitalizio, continuo in alcuni casi e periodico in altri, verso alti dirigenti, politici, banchieri, immobiliaristi, tecnici, docenti universitari, funzionari statali, manager di multinazionali, magistrati e superpoliziotti italiani. Tutti cittadini italiani accusabili d’intelligenza col nemico: da sottolinearsi che non c’è nemmeno la giustificazione di collaborazione con uno Stato del “Patto Atlantico”, perché circa cinquecento italiani (forse anche più) sarebbero a servizio di strutture multinazionali private, società che vendono i loro servigi agli Stati grazie all’aiutino di funzionari corrotti.
Insomma, una supercupola a servizio del nemico, pronta a far svendere pezzi d’Italia, ad aggiustare processi, a manovrare appalti nei lavori pubblici e forniture alle Pubbliche amministrazioni. La “Loggia Ungheria” non è sola e, forse, è stata soltanto un piccolo tassello, utile a intermediare l’aggiustamento di processi amministrativi. L’organizzazione, che Indro Montanelli appellerebbe dei “camerieri del nemico”, s’è sviluppata e implementata tra il 1993 ed il 2001 (durante la presidenza Bill Clinton): quindi l’albero s’è irrobustito, garantendo informazioni e affari ai vari Black Rock, Blackstone, Merrill Lynch, Citibank, Barclays Global Investors, hedge fund vari e poi anche varie telefoniche, informatiche e chimico-energetiche.
Il professor Giuseppe Guarino, giurista e accademico spentosi ad aprile 2020, spiegava che questo groviglio spionistico finanziario in danno dell’Italia sarebbe cresciuto esponenzialmente dopo il 1992, con Tangentopoli (ne parla anche Angelo Polimeno Bottai nel libro “Alto Tradimento”, raccogliendo l’inedita testimonianza del professor Guarino): così dopo la riunione sullo yacht Britannia, dove magistrati ed alti dirigenti di Stato s’accordavano sulla manovra “Tangentopoli-Mani Pulite”, si sviluppava nel Paese l’intelligence in favore delle multinazionali, delle privatizzazioni e delle svendite. Un esercito di traditori oggi legati a filo doppio alla fondazione di Hillary Clinton, con posti dirigenziali nei ministeri chiave, a Palazzo Chigi, nelle principali partecipate, in ferrovie ed autostrade, in Telecom, in Enel, in Eni, in Rai, in Finmeccanica… e dulcis in fundo in Leonardo.
Un groviglio d’ometti e donnicciole di bassissima tensione morale ed etica, ma utili allo scopo. “Mafia comanda e picciotto risponde” veniva detto ad Alberto Sordi ne il “Mafioso” (film di Alberto Lattuada). Si tratta d’un manipolo d’italiani ben posizionati, a cui verrebbe garantito un vitalizio (quello classico delle spie su conto estero intangibile) oltre alla buona posizione lavorativa in Italia, la sistemazione di figli, moglie ed amante: poi tutto il resto se lo procurano con l’intrigo acciuffando case e terreni alle aste (per l’occasione truccate).
Ma non compromettiamoci oltre, l’intelligence Usa ha tracciato tutto. Sa che gli spioni italiani hanno una rete che spazia dai media (giornali e tivù), alle banche, passando per tribunali e uffici fiscali vari (mandano prescritte le cartelle di sodali ed amici). Di questa gente non ci sarebbe traccia negli elenchi dei massoni depositati al Viminale dalle logge del Grande Oriente: le spie sono state scelte dalle grandi società estere scartando i massoni denunciati ed i personaggi pubblici con evidente esposizione politica. La cernita è stata fatta tra l’alta dirigenza felpata e silenziosa, tra le seconde e terze fila della politica, tra gli ufficiali meno esposti.
Ora in tanti si chiederanno fino a che punto a questi “camerieri” sarebbe stata garantita l’impunità, la scudazione di danaro e patrimoni? Di fatto a questi loschi figuri è stata garantita alternanza e avvicendamento nei ranghi dirigenziali (pubblici e privati) dello Stivale. Negli ultimi anni, per coprire anche i settori social e le varie influenze, le multinazionali hanno reclutato anche i Italia una decina d’influencer rese oltremodo ricche. S’evitano volutamente i nomi di questa gente in vista (dai dirigenti ai politici passando per gli influencer) perché, nel caso querelassero, si potrebbe finire nelle mani d’un magistrato collegato al “sistema”.
FONTE: https://www.opinione.it/politica/2021/07/16/ruggiero-capone_nomi-spioni-italiani-brogli-frode-elettorale/
Biglino: la menzogna al potere, con Davos o con Viganò
L’arcivescovo Carlo Maria Viganò condanna il Grande Reset che è in corso in questo momento. Dice cose assolutamente condivisibili: sono anche cose che, normalmente, vengono dette dai complottisti. Da un lato, però, possiamo (e dobbiamo) dire: ma che bravo, questo alto prelato della Chiesa, che ha il coraggio di denunciare una serie di eventi, situazioni, decisioni e programmi che stanno condizionando il presente e si preparano a condizionare la nostra vita, ancora di più, per il futuro. E quindi: bravissimo. Il problema qual è? Questo: si coglie la lotta tra due poteri, che si contendono il controllo del mondo. Perché monsignor Viganò, in realtà, è il sostenitore della restaurazione dell’antico potere della Chiesa. Alla base c’è un concetto biblico che, ancora una volta, condiziona le nostre vite: ed è per questo che è importante, sapere ciò che la Bibbia dice. Secondo Viganò, alla base di quanto sta accadendo oggi c’è «una grande menzogna, annunciata già dalle Sacre Scritture». E perlando del diavolo, che lui dà per vero e vivente, si domanda: «Cosa possiamo aspettarci, dal padre della menzogna?».
Dice Viganò: «E’ nostro dovere svelare l’inganno di questo Grande Reset, perché dietro a tutto questo c’è il piano diabolico che distrugge l’opera della creazione e vuole vanificare la redenzione». Ora, noi abbiamo già visto più volte come la creazione, nella Bibbia, non ci sia (non  c’è proprio: non c’è neppure il termine che la identifichi). Vanificare la redenzione? Ma “redenzione” da che cosa, visto che il peccato originale nella Bibbia non c’è, e quindi noi non dobbiamo essere redenti da nulla? Non nasciamo macchiati dal peccato originale, dunque possiamo vivere assolutamente tranquilli: non abbiamo bisogno di nessuna redenzione di questo tipo. «Alla base di questo modus operandi – insiste Viganò – c’è sempre e comunque una menzogna». E questo modus operandi «vuole distruggere ciò che la civiltà ha faticosamente costruito, nel corso dei millenni, sotto l’ispirazione della grazia divina». Cioè: per lui, la civiltà e la costruzione storica sono ispirate dal Dio della Bibbia: Dio che, nella Bibbia (lo abbiamo già visto moltissime volte) non c’è.
c’è proprio: non c’è neppure il termine che la identifichi). Vanificare la redenzione? Ma “redenzione” da che cosa, visto che il peccato originale nella Bibbia non c’è, e quindi noi non dobbiamo essere redenti da nulla? Non nasciamo macchiati dal peccato originale, dunque possiamo vivere assolutamente tranquilli: non abbiamo bisogno di nessuna redenzione di questo tipo. «Alla base di questo modus operandi – insiste Viganò – c’è sempre e comunque una menzogna». E questo modus operandi «vuole distruggere ciò che la civiltà ha faticosamente costruito, nel corso dei millenni, sotto l’ispirazione della grazia divina». Cioè: per lui, la civiltà e la costruzione storica sono ispirate dal Dio della Bibbia: Dio che, nella Bibbia (lo abbiamo già visto moltissime volte) non c’è.
Quindi, lui parla di menzogna – da parte di coloro che gestiscono il Grande Reset – proprio indicando la necessità di attuare cambiamenti radicali attraverso un falso pretesto. Dimentica però che la stessa costruzione del Cristianesimo romano ha alla base la madre di tutte le menzogne: cioè l’esistenza di un Dio nell’Antico Testamento e la definizione di Gesù Cristo come figlio di quel Dio. Ed è in questo che sta la lotta tra questi due grandi poteri: da un lato c’è un potere laico, che sta indubbiamente cercando di condizionare la vita del pianeta, e dall’altro c’è questo potere religioso, che vede la disgregazione al suo interno (ormai sotto gli occhi di tutti) e vorrebbe restaurare il suo antico potere. E allora identifica il nemico in questo potere laico, che probabilmente sostituirà il potere della Chiesa: potere che la Chiesa ha esercitato per duemila anni.
Quando cita il comunismo, Viganò ne parla come di un grande male, e giustamente (quando parla dello stalinismo, dello sterminio dei kulaki – 30 milioni di persone in due anni). Poi fa anche un cenno al nazismo: dice che è stato prima finanziato e poi combattuto, col pretesto di disgregare l’Europa, ma non fa neanche un cenno alle vittime del nazismo. Questo mi ricorda un altro grande inganno, un’altra grande falsità: quella delle profezie di Fatima. Per quanto riguarda il XX Secolo, infatti, la cosiddetta Madonna di Fatima ha parlato del “grande  male” che sarebbe stato il comunismo, ma non ha fatto un solo cenno – non una sola parola – nei confronti del nazismo. E qui, nelle parole di Viganò, ritroviamo lo stesso concetto reazionario della Chiesa: grande attenzione al male comunista, e scarsissima attenzione al male nazista.
male” che sarebbe stato il comunismo, ma non ha fatto un solo cenno – non una sola parola – nei confronti del nazismo. E qui, nelle parole di Viganò, ritroviamo lo stesso concetto reazionario della Chiesa: grande attenzione al male comunista, e scarsissima attenzione al male nazista.
Quindi, attenzione: se è vero che alla base del Grande Reset ci sono menzogne (che non hanno origini “diaboliche”, ma nascono dalla mentalità degli uomini che vogliono garantirsi il potere e costruire il dominio dei pochi sui molti), alla base dell’altra grande struttura di potere, quella che vuole combattere contro il Grande Reset, c’è la volontà (il tentativo, il desiderio) di restaurare un potere che per duemila anni ha condizionato e programmato la vita delle persone, uccidendone decine di milioni. Mi fa un po’ sorridere, monsignor Viganò, quando dice che uno dei modi in cui il Grande Reset si è realizzato, nel corso degli ultimi decenni, è stata l’industrializzazione, e quindi il convincere i contadini a lasciare il lavoro dei campi per passare all’impiego sicuro nelle fabbriche. Quelli che hanno la mia età ricordano molto bene il lavoro capillare dei parroci di campagna, che convincevano i contadini ad andare a lavorare nelle fonderie, nelle industrie, nelle raffinerie di petrolio.
Ce li ricordiamo tutti, quei sacerdoti che partecipavano a quello che, adesso, l’alto prelato del Vaticano condanna come un comportamento funzionale al “grande inganno” del Grande Reset. Quindi, come sempre: teniamo le menti aperte. Perché se da un lato prendiamo atto che tutta una serie di denunce fatte da Viganò sono vere, dobbiamo però ricordarci che sono fatte nel nome di un potere che avrebbe tanta voglia di restaurare se stesso, di riprendere il controllo totale delle coscienze degli uomini, sulla base di una menzogna che sta alla base di tutte le menzogne. Quindi, quando condanna le menzogne degli altri, questo potere dovrebbe pensare alle sue menzogne, che hanno procurato decine di milioni di morti. Sofferenze inutili, che ancora stanno procurando le lotte tra le religioni nel nome di un Dio. Quindi, ascoltiamo bene Viganò. Ma stiamo attenti a non distinguere tra un bene e un male, perché in realtà la volontà di potere si incrocia, e si sta combattendo. Ed è per questo che è importante conoscere sia l’uno che l’altro potere. Per parte mia, io cerco di diffondere un po’ di conoscenza biblica.
(Mauro Biglino, dal video “Da quale pulpito…“, pubblicato sul canale YouTube “Il vero Mauro Biglino il 20 giugno 2021).
FONTE: https://www.libreidee.org/2021/06/biglino-la-menzogna-al-potere-con-davos-o-con-vigano/
ECONOMIA
Navi, container, treni, metalli: il grande disordine
Le catene di approvvigionamento merci e materiali – chip ma anche di rame, terre rare e altri minerali necessari alla transizione energetica – sono supercongestionate. Al fondo di questo caos che inciderà sui prezzi, gli obiettivi climatici della Cina, l’inadeguatezza delle reti di trasporto e la speculazione.
Prima la pandemia, poi la tendenziale e forte ripresa dell’economia, insieme ad alcuni incidenti casuali (quale il blocco del canale di Suez e il recente focolaio di pandemia che ha rallentato le operazioni del terminal container cinese di Yantan-Shenzhen), con sullo sfondo l’accelerarsi della transizione ecologica e il boom dell’elettronica, tutti questi fattori insieme hanno contribuito a portare una grande confusione in alcuni settori dell’economia a livello mondiale. Partendo da quello dei trasporti internazionali e da quello dei metalli, il marasma si è esteso alla rottura nelle catene di approvvigionamento delle merci e ad un aumento dei prezzi di alcuni prodotti a livello globale e comunque a scossoni violenti, persino stupefacenti, come ha indicato qualcuno, del sistema del commercio internazionale. Questa confusione dovrebbe durare ancora soltanto per qualche tempo su alcuni fronti, mentre su degli altri dovrebbe invece accompagnarci a lungo.
Così, per quanto riguarda il primo aspetto, quello transitorio, sembra ormai compromessa, almeno parzialmente, la consegna delle merci natalizie da parte della Cina al resto del mondo. Non solo, la carenza di rifornimenti di chip dovrebbe durare ancora un anno mentre dovremo probabilmente convivere a lungo con la carenza e con rilevanti aumenti dei prezzi di alcuni metalli. Al centro di tutto, come sempre più frequentemente accade, c’è la Cina, economia in forte ripresa, anche con un rilevante anticipo rispetto agli altri grandi paesi, con la sua crescente sete di input produttivi e allo stesso tempo punto di origine di una grande mole di merci consumate dal resto del mondo.
I container e le navi
Grazie alla pandemia e alle sue conseguenze, nonchè poi alla ripresa improvvisa delle economie, i costi di affitto delle navi e dei container hanno raggiunto livelli record. I costi dei noli transoceanici sono aumentati almeno di cinque volte per le navi medio-piccole e non molto diversamente per quelle più grandi, mentre quelli dei container sino a 12 volte. Ora, nonostante lo sforzo per aumentare la produzione dei container in Cina e il varo di un piano di costruzione di nuovi vascelli, alcuni esperti prevedono che i problemi dureranno almeno sino ai primi mesi del 2022.
Il forte aumento delle spedizioni dall’Asia che il resto del mondo chiuso per la pandemia chiedeva con forza ha messo in crisi i flussi di traffico. Si sono verificati giganteschi colli di bottiglia nei porti occidentali e parallelamente nel flusso dei container. Tra l’altro, molti di quelli spediti dall’Asia verso il Nord America e l’Europa trovano ormai da parecchio tempo difficoltà a tornare indietro regolarmente per i problemi logistici e la mancanza di merci per riempirli al ritorno, nonché, almeno all’inizio, per i lockdown e le carenze di manodopera. Parallelamente si sono allungati di molto i tempi di consegna delle merci.
I produttori cinesi producono quasi il 100% di tutti i container del mondo (Zhou, 2021) e stanno operando al 100% della loro capacità produttiva nel settore, mentre si cerca di recuperare quelli in via di rottamazione e si organizzano programmi straordinari per far ritornare indietro quelli che giacciono nei porti occidentali. I cinesi, ma anche i coreani, stanno costruendo molte nuove navi, ma ci vuole come minimo un anno e mezzo per portarle al varo.
Come al solito le disgrazie sono sempre propizie a qualcuno e in questo caso si trovano a gioire le compagnie di navigazione. Tutte e sette le principali società del settore, dopo qualche anno di vacche magre, in presenza di una rilevante sovracapacità produttiva, prevedono di chiudere il 2021 con profitti tra i 10 e i 15 miliardi di dollari ciascuna (Martini, 2021), mentre anche il 2022 si presenta già come molto positivo.
Intanto i prezzi delle merci tendono a salire e in particolare dopo l’estate si temono aumenti rilevanti per molti prodotti, dalle auto agli elettrodomestici ai telefonini e agli addobbi natalizi. Soffrono dell’aumento del costo dei trasporti in particolare i settori che trattano merci povere, a basso valore aggiunto.
I treni
Le difficoltà del trasporto marittimo hanno contribuito a puntare i fari su di un mezzo alternativo, quello dei treni. I servizi ferroviari merci tra la Cina, l’Asia e l’Europa sono partiti in sordina una decina di anni fa, ma nel 2020 si sono registrati in totale ben 12.406 convogli, con un incremento di circa il 50% sull’anno precedente. Nel primo semestre del 2021 sono stati 7.377 quelli avviati tra la Cina e l’Europa, con un incremento del 43% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, che, ricordiamo, si situava nel pieno della pandemia (Zhong Nan, 2021). L’incremento dei carichi trasportati su rotaia è stato invece del 52%. Il servizio tocca ormai 168 città in 23 paesi.
Il treno è competitivo in termini di costi rispetto all’aereo e parecchio più veloce rispetto alla nave. Un convoglio ferroviario può impiegare 18 giorni per arrivare dalla Cina in Germania, contro 35 giorni via nave. La domanda del servizio è in forte crescita, ma la capacità di trasporto è limitata. Un treno può portare 50-100 container mentre una nave anche più di 20.000. Si stanno progettando nuove linee ferroviarie, ma anche in questo caso ci vorrà tempo per averle in esercizio. Un problema è quello che i treni partono pieni dalla Cina, ma tornano spesso vuoti dall’Europa.
Il boom dei minerali
Mentre il problema dei trasporti appare risolvibile nell’arco di qualche mese o poco più, ovviamente a meno di nuova sorprese, più complesso appare quello di molti minerali.
La spinta globale verso le energie pulite che sta acquistando molto vigore, comporta un vero e proprio boom per alcuni minerali critici, dal rame al litio, al nickel, al manganese, al cobalto alle terre rare, al silicio e così via. Anche il settore dell’elettronica, in piena crescita almeno in alcuni comparti, ha esigenze simili per quanto riguarda alcuni di questi minerali.
Il rame in particolare è al cuore delle produzioni per il miglioramento climatico. Il metallo rosso si usa in ogni applicazione, dalle turbine a vento ai veicoli elettrici. Un’auto elettrica consuma cinque volte più rame che non una tradizionale, mentre una turbina da 3-megawatt utilizza sino a 4,7 tonnellate del metallo (Hume, Sanderson, 2021). I progetti di nuove miniere del minerale sono al momento molto limitati, mentre la domanda per il metallo dovrebbe crescere fortemente.
Tutto questo porta alcuni a domandarsi se il rame non diventerà il nuovo petrolio, una materia prima strategica, dando vita anche ad un superciclo dei metalli pluridecennale. Bisogna considerare che anche altri metalli, quali il cobalto e il nickel, sono essenziali alla nuova economia. Il consumo di tali materiali dovrebbe aumentare di almeno sette volte tra il 2020 e il 2030 (Hume, Sanderson, 2021). Si pensi soltanto che la Cina deve investire 2.000 miliardi di dollari ogni anno per quaranta anni per arrivare alla neutralità carbonio. La crescita dei prezzi ha toccato anche comparti più tradizionali nel settore dei metalli e sta riguardando in particolare l’acciaio come specificheremo più avanti.
Non tutti i metalli sono in short supply e bisogna distinguere tra i rilevanti movimenti di fondo e una componente congiunturale che appare in qualche modo giustificabile dopo una pesante recessione. In ogni caso, anche di fronte a queste prospettive, per alcuni minerali, le imprese del settore sono piuttosto restie ad aumentare i loro investimenti.
Così, per alcuni il prezzo del rame deve ancora salire prima che ci si decida a investire. Molti investitori preferiscono usare le risorse disponibili per distribuire maggiori dividendi piuttosto che privarsene per usarli in una prospettiva certo, di maggiori redditi, ma parecchio lontana. Bisogna ricordare a questo proposito che ci vogliono una decina di anni per avviare un nuovo progetto nel settore.
C’è certamente anche una componente speculativa negli aumenti dei prezzi e la Cina, che assorbe una parte molto importante delle forniture mondiali, ha emesso nel maggio 2021 un avvertimento ai trader di materie prime e minerali, avvisando che adotterà un atteggiamento di “tolleranza zero” nei confronti della speculazione, la diffusione di false informazioni, l’accaparramento, le posizioni di monopolio. Ma ha anche ristretto il credito al settore e fermato alcuni progetti infrastrutturali. Nei giorni dopo l’annuncio molti prezzi si sono abbassati e la febbre speculativa sembra al momento calmarsi (Hale, 2021). I prezzi elevati aumentano i profitti delle società minerarie e di quelle dei trasporti marittimi, ma riducono quelli dei settori a valle e soprattutto quelli dei settori a bassi margini di guadagno.
La Cina
Per molto tempo le grandi quantità di energia generate dal carbone a basso costo ha permesso alla Cina di dominare l’esportazione di metalli, dal rame all’acciaio, contribuendo a mantenere bassi i prezzi. Ma ora regolamentazioni ambientali più severe sulle miniere, stabilimenti siderurgici, fonderie, insieme ai più elevati consumi interni, riducono le forniture e aumentano i prezzi ((Sanderson, Hume, Hale, 2021). Anzi, di recente la Cina ha posto dei dazi del 15% all’esportazione di acciaio.
Il paese asiatico è il più grande consumatore di metalli e derivati: produce il 56% del totale dell’acciaio mondiale e il 57% dell’alluminio, solo per citare due casi (Sanderson, Hume, Hale, 2021). Inoltre è un grande esportatore. L’acciaio conta per il 18% delle emissioni del paese e quindi la Cina deve limitare la produzione per ridurre i livelli di inquinamento. Nel piano quinquennale che va dal 2021 al 2025, Pechino promette di ridurre la produzione di 236 milioni di tonnellate, mentre diverse imprese trasferiranno delle produzioni fuori dal paese, come sta già cominciando ad accadere. Ragione per la quale già si avverte una pressione sui prezzi anche delle produzioni a valle, pressione che non si allenterà facilmente.
Testi citati nell’articolo
-Hale T., Iron ore prices drop after China warns of excessive speculation, www.ft.com, 24 maggio 2021
-Hume N., Sanderson H., Copper boom: how clean energy is driving a commodities supercycle, www.ft.com, 7 giugno 2021
-Martini D., Il vero costo della ripartenza è il prezzo record dei container, Domani, 26 giugno 2021
-Sanderson H., Hume N., Hale, China’s environmental goals fire up metal prices, www.ft.com, 10 giugno 2021
-Zhong Nan, China-Europe freight trains put BRI on fast track to cooperation, www.chinadaily.com, 10 maggio 2021
-Zhou C., Coronavirus : shipping rates to stay at « unprecedented » levels until pandemic brought under control, www.scmp.com, 3 giugno 2021
FONTE: https://sbilanciamoci.info/navi-container-treni-metalli-il-grande-disordine/
Inflazione e sudafricanizzazione

La minaccia a lungo termine. Un sudafricano brandisce un fucile nel tentativo di proteggere la sua comunità dai saccheggiatori.
La minaccia a breve termine
La minaccia a breve termine è l’aumento dell’inflazione. Con il picco del 5,4% anno su anno a giugno, diventa sempre più difficile negare che l’inflazione sia ora un problema in America. Certo, questa non è stata una novità per nessuno che ha fatto il pieno di auto di recente, ma come ha meditato un conduttore televisivo di Bloomberg durante un’apparente adlib venerdì sul picco dei prezzi delle auto usate, vive a Manhattan e non ha un’auto . Dato che Manhattan è la capitale dei media d’America, questo tipo di isolamento è probabilmente comune.
Siepi contro l’inflazione affidabili e inaffidabili
Nonostante le spaventose notizie sull’inflazione, l’ETF sull’oro preferito da tutti, lo Sprott Physical Gold Trust (PHYS) è stato piatto durante la settimana e il Bitcoin è sceso. Un punto che faccio nel video qui sotto è che la migliore copertura contro il rischio di inflazione che spinge al ribasso il mercato è una copertura contro il mercato stesso che scende.
VIDEO QUI: https://youtu.be/i1wB1BZ8-Iw
In quel video, utilizzo la nostra app per iPhone per trovare put ottimali per coprire un portafoglio da $ 1.000.000, ma lo stesso processo potrebbe essere utilizzato per coprire un portafoglio da $ 10.000 o $ 10.000.000.
La minaccia a lungo termine
La più grande notizia da una prospettiva globale nell’ultima settimana è stata la discesa nel caos in Sud Africa. Abbiamo scritto delle implicazioni per gli americani in un recente post ( Is South Africa’s Present America’s Future? ); ora, l’ex funzionario dell’amministrazione Trump Darren Beattie ha approfondito l’argomento in un eccellente post

Tra le altre cose, Darren spiega in dettaglio come il Sudafrica sia passato dalla produzione di un surplus di elettricità nel 1994 ai continui blackout di oggi:
Eskom, la società di servizi elettrici pubblici del Sudafrica, è uno dei più aggressivi che adottano BBBEE [Broad-Based Black Economic Empowerment, il principale programma di azione affermativa del Sudafrica]… BBBEE ha alimentato il decadimento dell’azienda elettrica sudafricana in ogni fase della il processo. Il paese ha due centrali elettriche costose e fallite perché la sussidiaria africana di Hitachi si è assicurata contratti basati su criteri di emancipazione nera piuttosto che su competenze reali. Eskom ha problemi con la fornitura di carbone perché ha favorito le compagnie minerarie di proprietà dei neri e ha persino spinto le aziende straniere a disinvestire dal paese. In un caso, il CEO di Wescoal si è dimesso dalla sua posizione solo perché avere un CEO bianco ha ostacolato la capacità dell’azienda di competere in Sud Africa.
Vale la pena leggere il post per intero.
Se vuoi restare in contatto
Puoi seguirci su Twitter qui , iscriverti alla nostra mailing list qui e iscriverti al nostro canale YouTube qui .
FONTE: https://www.zerohedge.com/news/2021-07-17/inflation-and-south-africanization
David Harvey, L’accumulazione come spoliazione
“Viviamo tempi pericolosi, ma anche adatti a esplorare nuove possibilità”. Così scrive David Harvey, pensatore marxista che si fa fatica a etichettare in una disciplina (chi ci ha provato, misurandone il successo su Twitter, lo ha messo al quarto posto tra i sociologi più seguiti al mondo, e al quindicesimo tra gli economisti, per dire). Il suo ultimo libro tradotto per Feltrinelli da Virginio B. Sala, Cronache anticapitaliste, deriva dal lavoro fatto per le “Anti-Capitalist Chronicles”, un podcast quindicinale nel quale dal 2018 Harvey “guarda al capitalismo attraverso lenti marxiste”, come si legge nella presentazione del progetto prodotto da Democracy at work. Lo stile è un continuo e alterno mix tra ricerca e militanza: Harvey, come ricordano i curatori del libro, è stato ed è un innovatore, che ha riversato i suoi 40 anni di studi sul marxismo nello spazio online, diventandone una star – le sue letture del Capitale, videocorso gratuito, sono state viste da oltre 4,5 milioni di persone in 200 Paesi.
Lettore rigoroso e filologico di Marx, ha accettato – all’inizio con un po’ di stupore, racconta – la proposta di riversare in un libro quel flusso di idee nato dagli eventi quotidiani, dal dibattito politico e dall’evoluzione dei suoi interessi. Quel che ne viene fuori non è però un’antologia, ma appunto un flusso di pensiero, che anche il lettore può a sua volta seguire con un po’ di stupore per l’attualità di alcune citazioni di Marx; con animo militante – il “che fare” è sempre didatticamente presente a conclusione di ogni tema proposto, e sono tutti veramente grandi, accettando la semplificazione a volte brutale; con curiosità, per l’evoluzione delle categorie marxiste dal capitalismo industriale al capitalismo delle piattaforme; e infine con la partecipazione che ogni titolo relativo al Covid 19 ormai ci sollecita, negli ultimi due podcast-capitoli scritti con la pandemia in corso.
Come si capirà, troppo vasta è la geografia dei temi per trattarli tutti in una breve recensione (alcuni titoli: le agitazioni globali del 2018-2019; l’aggiornamento della “breve storia del neoliberismo”, best seller di Harvey del 2005, al dopo crisi del 2007; le svolte autoritarie; la Cina; la finanziarizzazione; il cambiamento climatico; il cambiamento dei modelli di consumo; la revisione delle categorie classiche dell’accumulazione, dell’alienazione e del saggio del plusvalore…). Seguendo il modello del podcast, si può scegliere una lettura random e poi approfondire con la bibliografia e le domande poste a chiusura di ogni capitolo. Nel nostro caso, clicchiamo su due finestre. La prima è nell’applicazione delle lenti marxiste al capitale immateriale dei vincitori della innovazione tecnologica, le piattaforme digitali; la seconda è in quella che Harvey chiama “la politica anticapitalista ai tempi del Covid 19” e nel suo auspicio di una risposta collettiva al dilemma collettivo aperto dalla pandemia.
La grande spoliazione
Il potere gigantesco delle Big Tech è ormai riconosciuto come problema un po’ ovunque, tant’è che è stato coniato il termine di “techlash” per definire questa ondata avversa alle grandi piattaforme, che sta attraversando la politica e le autorità di controllo dei mercati dall’Europa agli Stati Uniti, dove il “capitalismo della sorveglianza” – lo ha battezzato Soshana Zuboff in un saggio molto fortunato – è nato. Proprio negli Stati Uniti i più ferventi teorici della necessità di spezzare i nuovi monopoli digitali, come Tim Wu e Lina Khan, sono diventati il primo consulente di Biden sulla tecnologia, la seconda il capo della Federal Trade Commission americana. Mentre l’Unione europea prepara un apparato di nuove regole per i dominatori dello spazio digitale, come Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft (anche detti “Gafam”).
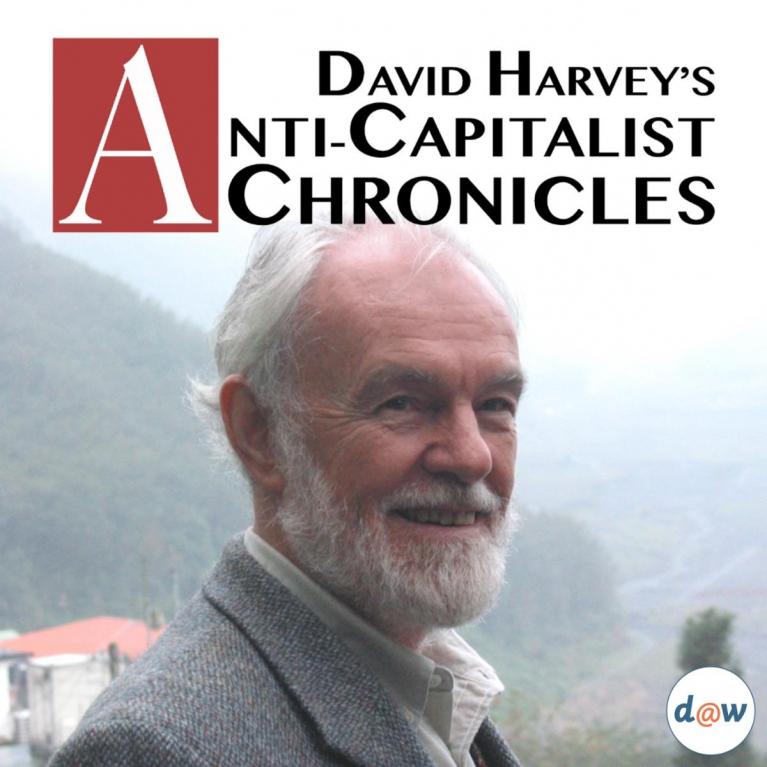
Per Harvey, quella delle grandi piattaforme è “accumulazione per spoliazione”. La si può raccontare partendo dalla constatazione molto semplice per cui qualunque giovane e geniale sviluppatore che inventa una app o un prodotto non sogna di realizzarlo, ma di venderlo a Google o a un altro dei giganti. Harvey affronta il tema partendo dalla distinzione marxiana tra l’accumulazione primitiva (quella che “costringe le persone a lasciare la terra, recinta i terreni e porta alla creazione di una forza lavoro salariata”) e l’accumulazione per spoliazione. In quest’ultimo caso, “la ricchezza già accumulata viene appropriata o rubata da certi settori del capitale, senza alcun proposito di investirla nella produzione”. È esattamente quello che fa Google quando assorbe piccole aziende, spesso personali. E in effetti tutte le Big Tech hanno fatto un enorme numero di acquisizioni negli ultimi anni, passate sotto i radar dell’antitrust perché tutte piccole, ma funzionali a eliminare i potenziali concorrenti e alimentare, come dice Harvey, “enormi conglomerati”. Ma allora queste aziende, nate nel cuore pulsante dell’innovazione planetaria non “fanno” niente? No, “un’azienda come Google è in parte coinvolta nella progettazione di nuovi vettori per la produzione, ma in prevalenza la sua attività è una forma di appropriazione mediante meccanismi di mercato”. Insomma, via via si passa dal capitalismo “industriale” a “forme di rendita del capitalismo”. Il che richiede, è la conclusione di Harvey che in ogni capitolo si chiede “allora, che fare?”, forme di organizzazione e protesta politica diverse dalle tecniche classiche dell’organizzazione di sinistra.
Mai sprecare una crisi
È il motto proprio del business, e accolto di buon grado anche della tecnica politica. Harvey prova a trasferirlo ai movimenti di protesta. La crisi è ovviamente quella del Covid 19, alla quale sono dedicati gli ultimi due capitoli del libro. In pieno lockdown chiuso nella sua casa newyorkese da “privilegiato”, Harvey si domanda: “che cosa pensa un anticapitalista di circostanze come queste?”. In primo luogo, sfata il luogo comune (in realtà diffuso solo all’inizio dell’insorgenza del Covid 19) per cui la pandemia è uguale per tutti: neanche per sogno, sia l’impatto della malattia che quello della crisi economica conseguente hanno aumentato le diseguaglianze di classe, genere, etnia. Poi la prende alla larga, ricorrendo alle teorie di Marx sul cambiamento tecnologico, sul suo impatto sul lavoro e sulle relazioni di potere, fino ad arrivare agli scritti sulla riduzione del lavoro necessario per vivere.
Ne deriva che la “cura” economica del post Covid non deve proporsi di farci tornare come prima: se – come dicevano le previsioni correnti ai tempi dello scritto – lo choc pandemico è costato 26 milioni di disoccupati negli Stati Uniti, vogliamo che questi tornino “a svolgere uno di quegli sgradevoli impieghi che avevano in precedenza?”. In altre parole: “non è il momento giusto per pensare seriamente alla creazione di una società alternativa?”. A chi pensa che l’idea di affrontare il virus e al tempo stesso il capitale sia pura illusione, Harvey risponde citando il fatto che nel pieno dell’emergenza si sono sperimentati sistemi alternativi, dalla assistenza alimentare gratuita ai gruppi più colpiti, a “trattamenti medici gratis” (ovviamente sconvolgenti nel panorama americano). Se il dilemma è collettivo, la risposta deve essere collettiva, argomenta lo studioso marxista. Forse era un ottimismo della prima ora del Covid, o forse qualche ulteriore appiglio si può trovare nel cambiamento del paradigma della politica economica dell’amministrazione Usa – ma scommettiamo che Harvey non concorderebbe con questa interpretazione “riformista”. Per saperlo, non resta che continuare a seguire i suoi podcast.
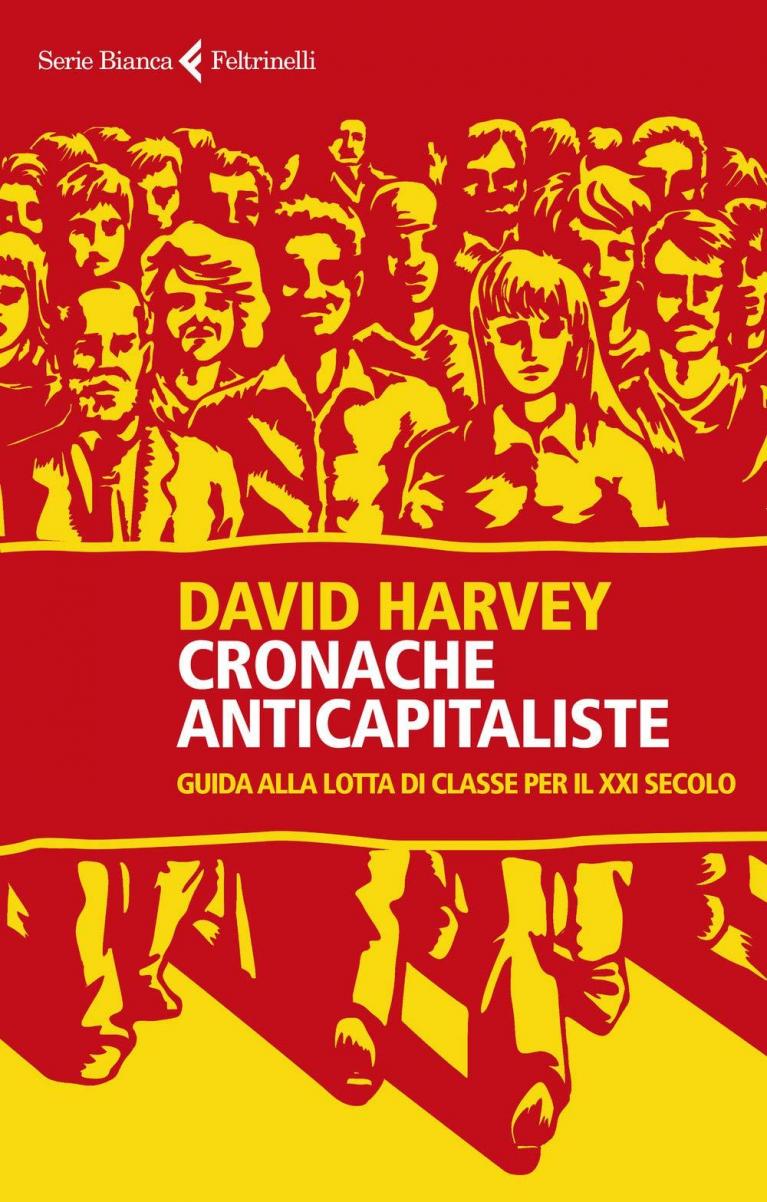
FONTE: https://www.doppiozero.com/materiali/david-harvey-laccumulazione-come-spoliazione
FINANZA BANCHE ASSICURAZIONI
La nuova politica monetaria della BCE: tanta liquidità, ma problemi sempre permanenti
Luglio 19, 2021 posted by Guido da Landriano

La scorsa settimana la BCE ha annunciato la nuova politica monetaria e un nuovo obiettivo di tasso d’inflazione, unica sua guida dato che, caso unico al mondo, la BCE non ha un obiettivo di tasso di disoccupazione.
Quindi cosa c’è di nuovo? “Appena sotto il 2 per cento”, la formulazione del 2003, è stata sostituita da “2 per cento”. Nel testo si fa anche riferimento alle conoscenze acquisite da allora sulla gravità della paralisi della politica monetaria che può verificarsi quando l’inflazione scende troppo. Quindi “la stabilità dei prezzi si mantiene meglio puntando a un obiettivo d’inflazione del 2% nel medio termine”, il che significa che, nel breve termine, questo obiettivo può anche essere superato.
Quindi la BCE si è data un obiettivo leggermente più flessibile rispetto a prima, con la possibilità di superamento della soglia per un breve periodo, diciamo qualche trimestre. Che strumenti ha a disposizione la banca centrle per centrare l’obiettivo? Eccoli:
- tassi di riferimento (deposito, rifinanziamento etc);
- le indicazioni strategiche di politica economica;
- le operazioni di rifinanziamento;
- gli acquisti di asset, che negli ultimi anni sono state le operazioni più utilizzate, anche per controllare i livelli di debito.
Questi strumenti non sarebbero stati utilizzati nel 2003 , ai primordi dell’Euro. Adesso invece, passo passo, sono diventati quasi comuni. Chi avrebbe pensato al QE del PSPP nel 2003, per non parlare poi dell’enorme PEPP. Ora queste cose sono diventate quasi comuni.
Ci so potrebbe chiedere: la Bundesbank e la Banca Centrale dei Paesi bassi, i cani da guardia, con gli austriaci, della rigidità nell’area euro, come hanno potuto accettare questi cambiamenti nella politica economica. Da un lato una serie di emergenze, a partire dalla crisi del debito al Covid, hanno indicato come una politica economica troppo rigida fosse controproducente per le stesse economie di questi stati, dall’altro hanno ottenuto anche qualcosa in cambio: ad esempio la BCE sta per introdurre un indice speciale che tiene conto dell’andamento dei valori immobiliari, indicatore che però rimarrà separato dal tasso d’inflazione, pur dando dei dati che comunque saranno considerati. Questo però potrebbe portare a un’ulteriore spaccatura fra paesi con valori immobiliari in crescita (Olanda e Germania) e altri con valori in calo o stabili (Italia).
Il problema è che la politica monetaria della BCE avrò salvato nel breve termine l’euro, ma non ha cancellato, anzi ha accentuato, i contrasti economici fra i vari paesi della BCE. Il tasso di equilibrio dell’area euro, quello che permette da un lato una crescita minima, dall’altro la sopravvivenza della moneta unica, e dall’altro ancora il non fallimento degli stati, è ormai così basso da essere negativo, il tutto senza però nessun vero ammodernamento delle strutture della UE e o degli stati nazionali. Gli interessi di inflazione potranno essere anche sopra il 2%, ma i problemi sono tutti li.
FONTE: https://scenarieconomici.it/la-nuova-politica-monetaria-della-bce-tanta-liquidita-ma-problemi-sempre-permanenti/
GIUSTIZIA E NORME
IMMIGRAZIONI
LA LINGUA SALVATA
Catabasi
ca-tà-ba-si
SIGNIFICATO Classicamente, discesa negli Inferi; ritirata; discesa
ETIMOLOGIA voce dotta recuperata dal latino tardo catàbasis, prestito dal greco katábasis, composto di katá ‘giù’ e básis ‘cammino’.
La discesa agli inferi (risuona un accordo tenebroso). Oddio, sì, la catàbasi è sostanzialmente questo, ma ha un respiro ampio: vediamo un po’ che cosa ci apparecchia, questa parola, che a vederla subito, senza nemmeno sapere che roba sia, ci ammicca col suo profilo greco bello e dotto, con l’accento elegantemente sdrucciolo.
La sua costruzione è semplice: ha origine nel greco katábasis, che significa in genere ‘discesa’, ed è composto di katá ‘giù’ e básis ‘cammino’. Ora, prima di affrettarci agli inferi dobbiamo rilevare come questo termine, in origine, indicasse anche (e forse specialmente) un andare ingiù dalle terre interne verso la costa del mare. A qualche persona infusa di gran sapere sovverrà che si tratta del contrario di anàbasi — anábasis in greco — che invece indica un salire, e un avventurarsi salendo nell’entroterra (noi che scocchiamo in auto e treni non ci pensiamo spesso, ma allontanarsi dal mare è quasi sempre un salire — magari ci appare più evidente in bici). Questo movimento verso il mare non resta nella catabasi italiana; però il fatto che l’anabasi, proprio per il suo addentrarsi, avesse il significato di ‘spedizione’, ha fatto sì che la catabasi acquisisse per bella simmetria quello di ‘ritirata’. Certo, in un registro letterario — e quindi sarà molto sostenuto e aulico il discorso in cui si parlerà della catabasi dell’esercito in rotta per la valle e la pianura.
Ma arriviamo al cuore nero e pieno di possibilità di questa parola. Dicevamo che si tratta di una discesa agli inferi; e se molti dizionari registrano questo significato relativamente alle anime della gente morta (ricordiamo che nel mondo classico l’Oltretomba era tutto sotterraneo, perfino i Campi Elisi), nella storia della letteratura sono però ben più celebri le catabasi in cui una persona viva discende negli inferi e ritorna.
È in effetti un topos, un elemento tematico letterario, universalmente ricorrente: ne parla la letteratura mesopotamica, ne parla Omero (nell’Odissea), c’è nell’Eneide di Virgilio, nella Farsalia di Lucano, nel Libro della Scala che racconta del viaggio oltremondano di Maometto — e ci ha scritto sopra una cosa anche un poeta fiorentino, senza troppa originalità.
Ebbene, questo significato di discesa infera fotografa naturalmente una spirale di dramma e disperazione che prende i connotati ora della sofferenza, ora dell’abiezione — ma anche del coraggio e della strenuità: la discesa all’inferno ha ampi significati figurati. Si può parlare della catabasi che porta un personaggio ameno e positivo a esprimere una natura malvagia, di un’incompresa catabasi nella depressione che chiede di essere accolta, della catabasi di chi scende a prestare servizio all’ultima gente del mondo.
Una parola grande nei significati, alta per ricercatezza — e un po’ impervia. Ma ha un tratto semplice e netto, che sa dare un orizzonte ampio di viaggio a una parabola personale.
FONTE: https://unaparolaalgiorno.it/significato/catabasi
LAVORO PENSIONI DIRITTI SOCIALI
Malpagati e pure umiliati: lo scandalo del lavoro cattivo
Imprenditori spesso rigidi e sordi, scuole e università in ritardo e politica distratta o presa da “altro”. Next Generation rischia di diventare il pasticcio generazionale. Blog di Fabrizio Binacchi

Quello del lavoro cattivo, cioè fuori regole o sottopagato, più che un problema è uno scandalo. Dopo tanti anni e decenni di provvedimenti più o meno intelligenti, l’agognato incontro tra domanda e offerta di lavoro è rimasta una chimera, nel senso che non si avvera. Navigator e collocamento sembran solo un gran tormento. Così si assiste al ben noto fenomeno che tanti cervelli e menti ma anche tante braccia e mani faccian la scelta di non stare nel Paese e di cercar fortuna all’estero in Australia o nel Regno Unito ma sempre con l’intento di far tornare i conti con le spese. Fuor di rima: perché un esperto di energia solare doveva accontentarsi di 800 euro in Italia quando a Londra prende 3400 sterline?
Con che faccia un manager magari da 300 mila euro l’anno offre a un ingegnere di 34 anni magari pieno di genio 600 euro al mese di apprendistato per 36 mesi? Vieni e poi vediamo. Pendolariato mentale. Con che faccia? Perché se ha già fatto la magistrale ed è uscito con lode deve fare un’altra triennale?
L’ematologa a 650 euro al mese con cento chilometri al giorno, e il bagnino a 400 euro al mese dalle 6 del mattino alle 20 di sera, e il cuciniere a 800 euro che sennò il ristorante non va ma anche il contatto è un po’ fritto misto, e il cameriere che si fa cento tavoli a 500 euro al mese? Malpagati e pure umiliati. Lo scandalo del lavoro cattivo investe parecchi Paesi e sicuramente l‘Italia.
Tutto questo mentre l’università e la scuola attendono di riformarsi invocando una indispensabile interdisciplinarietà che tarda ad arrivare perché tutti lo ammettono che ci vorrebbe un po’ di ingegneria a giurisprudenza, ci vorrebbe un po’ di legge a biologia, ci vorrebbe filosofia a chimica e dappertutto una bella spruzzata di psicologi, eppure dopo tanti proclami e lamenti siamo ancora nei progetti latenti.
E l’imprenditoria? Beh quella è un po’ così in talune zone avanzata e innovativa in altre un po’ sorda rigida e poco reattiva, aziende aperte e altre molto meno, e quindi che si fa ci si butta sul pubblico e sul sindacato che tutto non posson fare. E’ vero che la politica ha lanciati la Garanzia Giovani ma vi prego di chiedere in giro se è stata vera garanzia e per chi, se per i giovani o per altri soggetti non bisognosi. Si ha notizia di giovai partiti garantiti sulla carta e poi reietti alla prima scadenza.
Morale della favola dopo tanti anni siamo ancora qui con l’ascensore del lavoro ancora bloccato chi lavora è un po’ fortunato chi non lavora o ha lavoro cattivo è in mezzo al guado e un po’ guadato, parliamone seriamente perché aventi così non si può andare e la Next Generation EU rischia di diventare la Past Generation BOH, nel senso cacofonico del pasticcio generazionale, o poco più.
C’è purtroppo tanto lavoro cattivo e malpagato in giro per il Paese e solo il lavoro buono e i contratti corretti potranno rendere più buona l’Italia.
Fabrizio Binacchi
FONTE: https://www.pensalibero.it/incontri-malpagati-e-pure-umiliati-lo-scandalo-del-lavoro-cattivo/
PANORAMA INTERNAZIONALE
“L’Unione europea ha portato la pace”
Come ci fregano con la fallacia “post hoc, ergo propter hoc”
Post hoc ergo propter hoc significa, letteralmente, “dopo di ciò, quindi a causa di ciò”. Vuol dire accreditare un fatto di essere la causa di un altro solo perché accaduto prima.
Tale fallacia rientra nel novero di quelle informali di inconsistenza dette anche “fondamenta cedevoli”. Come rivela la parola, si tratta di argomenti basati su presupposti infidi e poco solidi, come le sabbie mobili. E tuttavia bisogna stare comunque attenti perché essi tendono ad aggirare la nostra naturale attitudine all’analisi critica e al ragionamento logico, e quindi a persuaderci.
Il sofisma in questione viene anche ricompreso all’interno dei cosiddetti non sequitur (letteralmente: non segue, non consegue) e può essere alternativamente designato come fallacia della falsa pista perché si basa su una relazione causale erronea.
Facciamo un esempio: 1) il mattino arriva sempre dopo che il gallo ha cantato; 2) quindi, il sorgere del sole è causato dal re del pollaio. Ovviamente, questo è un caso limite e fa ridere – anche i polli – per la sua assurdità. Eppure, non avete idea di quanto spesso la “scorciatoia” sia utilizzata non già inconsciamente dai bambini in età prescolare, ma consapevolmente dagli adulti con intenzioni manipolatorie.
Una variante del post hoc ergo propter hoc è il cum hoc ergo propter hoc (significa “insieme a ciò, quindi a causa di ciò”). Ad esempio: poiché è arrivato Ronaldo e la Juve non ha vinto la Coppa dei Campioni, allora la Juve non ha vinto la Coppa dei Campioni perché ha comprato Ronaldo. Sennonché, non è scritto da nessuna parte che il campione dei campioni debba vincere (o farti vincere) per forza il trofeo più ambito.
Oppure: poiché lo Stato ha aumentato il deficit quando sono andati al governo i gialloverdi, allora i gialloverdi hanno causato l’aumento del deficit. Non è detto, infatti, che il deficit dell’anno in corso sia colpa delle politiche di un nuovo governo. Spesso dipende dalle scelte del governo precedente o, addirittura, da anomalie strutturali o di sistema come quelle che affliggono l’euro e l’Unione europea.
Ma veniamo, appunto, al caso della UE e delle argomentazioni farlocche utilizzate per rinfocolare il suo “mito” presso il grande pubblico: la strategia del post hoc ergo propter hoc è stata – ed è ancor oggi – una delle più impiegate.
CASO VIGANO’: chi è il vero autore degli scritti di mons. Viganò?
Chi è il vero autore degli scritti dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò negli anni 2020-2021? Proviamo ad offrire una risposta alla domanda che abbiamo sollevato su Corrispondenza Romana iniziando da un metodo sicuro: l’analisi e la comparazione degli scritti con i testi di altri autori rintracciabili sul web. Ciò che in gergo scientifico si chiama ricerca stilometrica.
Ebbene, l’analisi degli elementi lessicali e stilistici ci conduce a un solo possibile autore: “Cesare Baronio”, o “Baronius”, creatore e autore, dal 2010 al 2020, del blog Opportune Importune (ATTENZIONE alle ore 10 del 23 giugno, poco dopo la pubblicazione dell’articolo, il sito Opportune Importune è stato prontamente rimosso e per questo tutti i link dell’articolo non sono più raggiungibili. Una versione archiviata del sito è comunque consultabile a questo link. Se la nostra analisi stilometrica non fosse esatta, perché “Baronius”, o chi per lui, ha rimosso il sito Opportune Importune?)
“Cesare Baronio” è però a sua volta uno pseudonimo e il passo successivo sarà quello di cercare di svelarne l’identità.
Abbiamo condotto un’ampia analisi delle assonanze di stile e di contenuto tra i testi di Baronio e quello che chiameremo, da adesso, Viganò II, per distinguere i suoi scritti del 2020-2021 da quelli, ben diversi, del Viganò I, degli anni 2018-2019. Ci limitiamo, per ragioni di spazio a qualche esempio.
Comune a Baronio e a Viganò II è l’attribuzione ai progressisti dei termini “contro-chiesa”, “setta conciliare” (qui; qui o “novatori” (qui; qui).
Il Concilio Vaticano II è più volte definito da entrambi come un “idolo”. Per Baronio, finché «l’idolo conciliare non sarà abbattuto, assieme alla infausta memoria dei suoi artefici, sarà impossibile punirne i gran sacerdoti che assediano Roma da cinquant’anni» (10 gennaio 2013, qui). Anche Viganò II, nella sua recente Intervista sulla Liturgia definisce il Vaticano II un idolo e, come Baronio, stabilisce una equazione Vaticano II – Novus Ordo Missae.
Baronio e Viganò II, quando si riferiscono al Novus Ordo di Paolo VI, parlano sempre di «rito riformato» o «rito montiniano». Viganò II scrive che «gli artefici di quella liturgia» furono «prelati spesso in sospetto di appartenenza alla Massoneria, notoriamente progressisti» (qui; Baronio parla a sua volta di «un rito composto da prelati notoriamente progressisti e massoni» (25 novembre 2018, qui).
I libri della nuova liturgia, per Baronio sono «messali stampati la cui funzione era quella di canovaccio cui far riferimento per le edizioni nelle diverse lingue nazionali» (15 gennaio 2013, qui. Per Viganò II questi libri liturgici «sono pensati come un brogliaccio, un canovaccio alla mercé di attori più o meno talentuosi alla ricerca del plauso del pubblico» (Qui).
Per Baronio «l’offertorio scompare del tutto per far posto a una preghiera giudaica di sapore panteistico» (25 novembre 2018, qui: https://opportuneimportune.blogspot.com/2018/11/questa-o-quella-per-me-pari-sono-in.html); Viganò II la definisce questa preghiera «offertorio talmudico» (qui).
Secondo Viganò «la cosiddetta “casula gotica” nelle forme che hanno preceduto il Concilio, soprattutto in Francia, è diventata quella specie di poncho che dopo il Concilio ci è stato spacciato come recupero della forma originale», ma si tratta di «un falso storico oltre che liturgico» (qui). Baronio aveva scritto che: «la casula conciliare è un orrido poncho che nulla ha a che vedere con la planeta descritta da San Carlo Borromeo (Instructionum fabricae, 1557), che troviamo raffigurata in moltissimi affreschi, quadri, miniature e smalti sin dal Medioevo» (11 gennaio 2014, qui).
Viganò denuncia «i tentativi di rendere presentabile la liturgia riformata con operazioni di maquillage oggettivamente inutili» (qui). Baronio scrive che le «operazioni di maquillage rituale al Novus Ordo sono a nostro avviso destinate, nella maggior parte dei casi al più infelice naufragio» (15 gennaio 2013, qui).
Si potrebbe continuare all’infinito, ma ciò che più conta, al di là delle coincidenze verbali è il medesimo tono, che esprime una compiaciuta conoscenza liturgica, teologica e storica, che Baronio ha ostentato per dieci anni nel suo blog, ma che risulta totalmente assente dai due anni di interventi pubblici di Viganò I.
Ma chi si cela dietro lo pseudonimo di Cesare Baronio (1538-1607), il celebre cardinale e storico oratoriano, allievo di san Filippo Neri?
Si potrebbe dire che poco importa la soluzione del mistero, perché ciò che conta, non è “chi” l’ha detto, ma “cosa” viene detto. Il problema però nasce proprio da alcune affermazioni stravaganti di Baronio-Viganò II, soprattutto in materia di escatologia e “Gran Reset”, che pongono inquietanti interrogativi sulla vera identità del consulente teologico-liturgico dell’arcivescovo milanese.
Purtroppo, dietro lo pseudonimo di Cesare Baronio sembra celarsi, non un teologo di sicura dottrina, ma un personaggio non privo di intelligenza e di cultura ecclesiastica, ma mancante di quella coerenza ed integrità che rende affidabile un collaboratore. Un personaggio che nella sua vita ha assunto, e continua ad assumere molteplici identità e che con l’ultima identità assunta, quella dell’arcivescovo Viganò, realizza ciò che forse ha sempre desiderato: presentarsi come un uomo di Chiesa, senza gli obblighi pastorali e morali che questa alta vocazione comporta.
A questo punto non ci resta che fare il nome del personaggio, ricorrendo non a voci generiche ma a documenti e fonti, da noi controllate: il nome dell’“eminentissimo Cesare Baronio” è Pietro Siffi.
Ma chi è costui?
Dobbiamo partire da una data specifica. L’8 maggio 2020, Mons. Viganò lanciò un appello contro il “Nuovo Ordine Mondiale” , denunciando «la nuova torre di Babele, il castello di carte del Covid, la farsa dei vaccini, la frode del Great Reset», a cui apposero le loro firme i cardinali Gerhard Müller Giuseppe Zen Zekiun e Robert Sarah, che l’ha poi ritirata. Questo appello fu il primo documento a suscitare forti interrogativi nel mondo cattolico a lui vicino, fino a spingere alcuni suoi amici ed estimatori a non sottoscriverlo.
Quel che fin da allora si seppe è che Mons. Viganò si rivolse a un suo collaboratore per predisporre la pubblicazione e la sottoscrizione dell’appello. In quel mese di maggio il collaboratore inviò a gruppi e personalità del mondo cattolico un avviso «IMPORTANTE E URGENTE!» in cui, «su richiesta di Sua Eccellenza Mons. Viganò», rivolgeva una richiesta di adesioni al documento, da inviare a suo email personale.
Ebbene, nell’avviso di maggio 2020, il nome e l’e-mail del collaboratore di Mons. Viganò incaricato della raccolta delle firme era quello di Pietro Siffi, un personaggio conosciuto e discusso nel mondo tradizionalista italiano.
Pietro Siffi è nato a Venezia l’11 settembre 1969. Riceve la Cresima nella Parrocchia S. Zaccaria e Atanasio il 22 maggio 1984. Dopo gli studi al Liceo “Marco Foscarini” di Venezia, entra nella Fraternità Sacerdotale San Pio X dove nel Seminario “Saint Curé d’Ars”, a Flavigny sur Ozerain (Francia), il 1° febbraio 1990 riceve la Cresima “sub conditione”. Due giorni dopo riceve a Flavigny la tonsura, divenendo membro della FSSPX. Ma dopo qualche tempo lascia, o è costretto a lasciare, la Fraternità. Non ne conosciamo i motivi, così come non sappiamo quali sono i motivi che qualche anno dopo lo spingono a lasciare l’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote di Gricigliano dove entra (ed esce) come seminarista.
Dal 1990 al 1994 Siffi frequenta l’Università della Sorbona (qui, poi, per qualche tempo se ne perdono le tracce, anche se qualcuno lo ritiene autore di un imbarazzante libro pubblicato sotto pseudonimo.
Di sicuro Pietro Siffi continua a coltivare i suoi interessi ecclesiastici. Nel 2007, per i tipi di Marietti Editore, cura la riedizione del Compendio di Liturgia Pratica di padre Ludovico Trimeloni con la prefazione del cardinale Darío Castrillón Hoyos, presidente della Pontificia Commissione Ecclesia Dei.
Nel Compendio di Trimeloni, Siffi si presenta come Presidente dell’Archivum Liturgicum di Ferrara. Il 14 marzo 2007 dal blog Archivum liturgicum, “Baronio” o “Baronius” annuncia che di lì a poco uscirà il Compendio di liturgia pratica (qui), ma il primo annuncio della pubblicazione dell’opera risale addirittura al 25 settembre 2006 e Siffi è presentato come presidente dell’Archivum Liturgicum Sacrosanctae Romanae Ecclesiae…
Già si annuncia che Benedetto XVI liberalizzerà l’antica liturgia romana . Evidentemente Baronio/Siffi ha buone informazioni dal mondo tradizionale e vaticano e nel 2007 pubblica un libro sulla Messa di San Pio V (qui; qui).
Un articolo di Roberto Beretta su Avvenire del 25 gennaio 2008 recensisce in termini tutt’altro che elogiativi la terza edizione del Compendio di liturgia pratica di Trimeloni-Siffi, giunto alla seconda ristampa. Avvenire del 29 gennaio 2008 ospita la replica di Siffi che si presenta come “Pietro Siffi degli Ordelaffi conte di Sassorosso” (vedi qui). In realtà nel Libro d’oro della nobiltà italiana pubblicato dal Collegio Araldico, Edizioni 1986-1989 e successive, non risulta l’esistenza di nessun conte Siffi degli Ordelaffi.
Siffi non è solo uno scrittore e liturgista tradizionalista. È un imprenditore. Nel 2010 crea a Ferrara “Ars Regia” (qui), che presenta in maniera “morbida” e seducente, come «uno studio di interior design specializzato nella proposta di complementi d’arredo di prestigio e di esclusivi tessuti d’arte». «I nostri complementi d’arredo permetteranno di dare un tocco di sottile eleganza e di charme alla propria dimora o ad un locale alla moda, differenziandosi dalle scontate proposte di grande diffusione e conferendogli un comfort decisamente esclusivo e glamour, dove con questo termine non si intende la semplice bellezza ma un atteggiamento, una sensazione, uno stato d’animo, con tutte le implicazioni di eleganza, sensualità e seduzione. L’immagine alla moda, il fascino colto ed evocativo dell’Oriente e dell’India, il lusso immaginifico e inconfondibile che richiama le famose location della Costa Azzurra, della Grecia, della Spagna, o della California sono tutti elementi che possono migliorare radicalmente l’aspetto di una residenza privata, un locale sul mare, un lounge bar: passione per l’abitare e per il vivere, per il calore domestico ma anche per l’estroso fervore mondano».
Nel corso della recita dell’Angelus del 10 ottobre 2010, appare un nuovo stemma papale di Benedetto XVI, ornato della tiara secondo l’antico uso. Siffi, creatore dello stemma, commenta: «Questo stemma, interamente ricamato a mano, è stato realizzato dall’atelier ferrarese di paramenti sacri Ars Regia e ripropone lo scudo con gli emblemi del Pontefice e il Pallio ornato di croci rosse. (…) La differenza rispetto al modello precedente – che alcuni attribuiscono al Cardinal Montezemolo – è che questo stemma reca nuovamente il triregno – la triplice corona del Sommo Pontefice – anziché la mitria, ripristinando l’antico uso, cui non aveva rinunciato nemmeno Giovanni Paolo II».
Nell’Angelus del 24 ottobre 2010 lo stemma misteriosamente apparso, altrettanto misteriosamente scomparve. Qui il commento di Baronio, che, come molti sanno è lo pseudonimo scelto da Pietro Siffi per continuare, sul nuovo blog Opportune Importune, inaugurato nel 2010, le sue dotte disquisizioni in campo teologico e liturgico.
Baronio difende Pietro Siffi e Ars Regia, poi replica ad alcuni con stile ampolloso e un po’ effeminato: «Mi pare che su Pietro Siffi gravi una sorta di ostracismo molto ipocrita, alimentato non tanto dai concorrenti oggi più in auge, quanto da alcuni meschini personaggi azzimati e démodé, che trascorrono il proprio tempo a denigrare la vita altrui, non avendone una propria. (…) La cosa sconcertante è che queste conventicole di teatranti organizzano pontificali in sedicesimo, dipanando metri e metri di seta marezzata tra il tinello e la camera da letto, e non si peritano di ostentare anche su internet tristissime camerucce debordanti di pizzi e merletti, mediocri salottini anni Venti con gli strapuntini, i tappetini, il quadretto del Duodecimo benedicente, un cappello prelatizio con fioccature da tenda, spille, gemelli fatti con i camei di mammina, occhiali d’oro, grammofoni e tutto il repertorio del trovarobato da amica di nonna Speranza.
(…) Credo che prima o poi Siffi o chi per lui si stancheranno di sopportare questi continui attacchi e inizieranno a render pan per focaccia – come si suol dire – sbugiardando una volta per tutte questi svirilizzati borghesucci senz’arte né parte, tanto ricchi di velleità snob quanto poveri di senso della misura. E sono certo che se si scoprissero certi altarini, se si portassero alla luce certe scomode verità, forse la finirebbero di dar noia al prossimo…» (vedi qui).
Nel 2011 Siffi fonda con Fabio Zardi un atelier di planning e decorazione che nel 2019 è diviso in due aziende: Fabio si occupa di floral design e decorazione, Pietro si dedica a planning e organizzazione di eventi anche matrimoni (vedi qui).
Siffi passa con disinvoltura dall’attività culturale e letteraria alla liturgia, dagli arredi sacri all’organizzazione di matrimoni ed è su quest’ultimo campo che scopriamo una sconcertante rivelazione: il poliedrico personaggio organizza anche matrimoni gay o, come si dice in gergo, “gay wedding”!
Sul sito di Pietro Siffi troviamo, tra l’altro, il “Project tag: matrimonio gay” e il servizio del “matrimonio” di due uomini, Arman e Dylan, nell’isola greca di Santorini con tanto di video.
L’agenzia di viaggi omosessuali Travelgay definisce Santorini come «una splendida isola, calda e ospitale situata nel Mar Egeo, dopo Mykonos senza dubbio la più apprezzata dal mercato Italiano e amata molto anche dal mercato gay e lesbo» (qui).
Anche il socio o ex socio di Siffi, Fabio Zardi si occupa di gay wedding. Curioso notare che il numero di “phone” di Zardi (qui) coincide con quello di Siffi (qui).
Il ghost-writer di mons. Viganò, l’arcivescovo che ha sempre giustamente denunciato l’esistenza di lobby gay all’interno della Chiesa (qui; qui ), è dunque un personaggio gay-friendly ?
In questo caso, l’arcivescovo Viganò, che è un rispettabilissimo prelato, rischia di perdere la sua credibilità e deve rendersi conto che potrà riacquistarla solo quando muterà il tono e i contenuti dei suoi interventi pubblici, incautamente affidati ad un controverso collaboratore. Non si può separare ciò che pubblicamente appare sotto il nome di mons. Viganò dall’identità di chi sembra essere l’autore dei suoi scritti.
Chiediamo a questo punto a mons. Viganò: è vero o no che egli si serve, in tutto o in parte, dell’aiuto di Pietro Siffi? Mons. Viganò era a conoscenza delle molteplici attività di Siffi?
Ma la domanda più importante che gli rivolgiamo è questa: Mons. Viganò è disposto a prendere pubblicamente le distanze dal personaggio che noi suggeriamo possa essere il suo ghost-writer?
Mons. Viganò è un uomo forse temerario, ma certamente leale. Gli chiediamo di dire la verità, perché la verità riscatta da qualsiasi errore, mentre la menzogna carica l’errore, anche incolpevole, di una grave responsabilità morale.
Per quanto riguarda Pietro Siffi non abbiamo voluto entrare nella sua vita privata, che a lui solo appartiene, ma ci siamo limitati a far conoscere ciò che di lui è pubblicamente noto, anche sotto diverse identità e travestimenti. Anche a lui chiediamo di assumersi la sua responsabilità, misurandosi con il suo vero nome, nel dibattito intellettuale del nostro tempo, a cui ha dato e potrà continuare a dare il suo contributo.
Da parte nostra ci siamo mossi sulla scia delle raccomandazioni che san Pio X dava ai giornalisti e Leone XIII dava agli storici: la Chiesa non ha mai paura della Verità.
FONTE: https://www.corrispondenzaromana.it/caso-vigano-chi-e-il-vero-autore-degli-scritti-di-mons-vigano/
POLITICA
SCIENZE TECNOLOGIE
L’esperimento di Tuskegee: la più vergognosa ricerca medica nella storia degli Stati Uniti
SINDEMIA
11 MAGGIO 2021
È «Sindemia» quando la malattia colpisce tutti, ma il modo in cui ognuno la subisce è diverso. Il podcast di Stefano Bises con I Diavoli.
FONTE: https://www.idiavoli.com/it/article/sindemia
STORIA
PREGHIERA DELL’ALPINO
Post Facebook – 4 gennaio 2018

25 luglio 1943: fu colpo di stato?
Vittorio Emanuele III esercitò il potere secondo l’articolo 65 dello Statuto: “Il Re nomina e revoca i suoi ministri”. Come a suo tempo osservò Luigi Einaudi, monarchico e presidente della Repubblica, il Re mostrò che “la prerogativa sovrana può e deve rimanere dormiente per lunghi decenni e risvegliarsi nei rarissimi momenti nei quali la voce unanime, anche se tacita, del popolo gli chiede di farsi innanzi.

“Lento pede” verso la verità storiografica
Ogni anno un piccolo passo avanti verso la verità sul 25 luglio 1943. Quel giorno, a conclusione di un colloquio di venti minuti iniziato alle 17 a Villa Savoia, Vittorio Emanuele III revocò Benito Mussolini da capo del governo e lo sostituì con il Maresciallo d’Italia Pietro Badoglio. Secondo Luigi Salvatorelli e altri studiosi e polemisti fu il terzo “colpo di Stato” messo a segno dal sovrano in un trentennio, dopo la dichiarazione di guerra all’impero d’Austria-Ungheria il 24 maggio 1915 e l’insediamento del governo Mussolini il 31 ottobre 1922. In un saggio del 1953 Elio Lodolini denunciò La illegittimità del governo Badoglio (ed. Gastaldi). Troppi però trascurano che l’ingresso nella Grande Guerra fu previamente approvato dal Parlamento e che il 16 novembre 1922 il governo Mussolini alla Camera ebbe il voto favorevole di tutti i partiti costituzionali, i cui rappresentanti del resto ne facevano parte, compresi i popolari di don Sturzo, i demosociali di Colonna di Cesarò e i demoliberali capitanati da Giolitti, Orlando, Salandra, e ottenne il “si” quasi unanime del Senato.
Re costituzionale, Vittorio Emanuele III operò con l’avallo delle Camere sulla base dei poteri di “capo supremo dello Stato” e comandante delle forze armate, come stabilito dall’articolo 5 dello Statuto promulgato da Carlo Alberto il 4 marzo 1848. Il 25 luglio fu un’eccezione e in quali termini? La revoca di Mussolini da capo del governo può essere imputata al re quale arbitrio incostituzionale? Il sovrano abusò del regio potere sostituendo il duce con il duca di Addis Abeba?
In Come muore un regime. Il fascismo verso il 25 luglio (ed. il Mulino) Paolo Cacace, studioso di istituzioni e politica estera e autore dell’intrigante saggio Quando Mussolini rischiò di morire (ed. Fazi),mira a mettere ordine nelle “cordate” che lavorarono al “cambio” al vertice del governo di un’Italia ormai militarmente sconfitta, con la Sicilia già invasa dagli anglo-americani e dopo il bombardamento dell’aviazione americana su Roma il 19 luglio, proprio mentre Mussolini incontrava per l’ennesima volta Hitler, precisamente nella villa dell’industriale e finanziere Achille Gaggia, non lontano da Feltre, raggiunta dai due in aereo sino a Treviso, in treno fino a Feltre e infine in auto.
Pressato dai vertici delle forze armate, il duce si proponeva di chiedere che, con i buoni uffici del Giappone (in guerra contro gli USA e i suoi alleati occidentali ma non contro la Russia), la Germania imboccasse la via di un armistizio con Stalin per rovesciare la sua potenza di fuoco verso il Mediterraneo. Diversamente l’Italia, ormai soccombente e con armate disperse all’estero, sarebbe stata costretta a una pace separata. Hitler, invece, ancora sicuro di sconfiggere i sovietici (che proprio in quei giorni lanciarono l’offensiva vincente) e famelicamente bisognoso di sfruttare le risorse delle terre soggiogate, per due ore deplorò la resa degli italiani in Sicilia, a volte quasi senza combattere, e prospettò la completa subordinazione delle loro infide truppe a generali tedeschi. L’incontro si risolse in un monologo di Hitler, che ventilò anche il possesso di armi segrete invincibili: le future V1 e V2, mentre però gli USA lavoravano all’atomica.
Rientrato pilotando personalmente l’aereo nella Roma sconvolta dai bombardieri statunitensi (3.000 morti, 10.000 feriti, rovine immense nel quartiere San Lorenzo), Mussolini dichiarò al generale Vittorio Ambrosio, capo di stato maggiore generale, di voler a scrivere a Hitler quanto non gli aveva detto nell’incontro. Troppo tardi…
Nel paragrafo “bombe nella villa degli arcani”, Cacace torna a indagare sull’attentato ordito dal maggiore Cesare Del Vecchio e dal capitano Antonio Giuriolo (ufficiali degli alpini reduci dalla campagna di Russia) per uccidere il fuehrer e il duce al loro arrivo a Villa Gaggia; attentato sfumato perché, con i commilitoni pronti ad agire, essi vennero trasferiti altrove pochi giorni prima del convegno. In pagine dense di allusioni e di “forse”, l’autore ripercorre il reticolo di vaghe connivenze tra militari, esponenti del partito d’azione, socialisti, repubblicani, come Cino Macrelli, accenna a un colloquio tra l’insigne latinista Concetto Marchesi, comunista, e il generale Raffaele Cadorna e conclude che secondo l’azionista Ugo La Malfa fu il Vaticano a imporre l’“alt” all’esecuzione del “colpaccio”. Aggiunge, quasi per inciso, che l’intrigo era forse noto a Giuseppe Bottai, il gerarca (stranamente antisemita) che legò il nome alla Carta della Scuola.
Quanti “figli della Vedova” nel Gran Consiglio…
Generoso dispensatore dell’etichetta di massone a politici, militari e grandi affaristi (Vittorio Emanuele Orlando, a sua detta addirittura affiliato alla loggia “Propaganda massonica” del Grande Oriente d’Italia; Pietro Badoglio, classificato come “massone coperto”; Armando Diaz, “in odore di loggia”; Giuseppe Volpi e Vittorio Cini, entrambi intrinseci di Angelo Gaggia, e un lungo elenco di generali la cui iniziazione in realtà non è affatto documentata), Cacace non scrive che, a differenza dei predetti, proprio Bottai, “dottore in giurisprudenza, residente a Roma in via Ancona 65”, il 20 aprile 1920 era stato iniziato “apprendista massone” nell’“officina” romana “La Forgia”, all’obbedienza della Serenissima Gran Loggia d’Italia (GLI) e fu radiato per morosità il 19 maggio 1923, dopo la dichiarazione di incompatibilità tra fasci e grembiulini, deliberata dal Gran Consiglio del Fascismo su impulso dei nazionalisti e con la consulenza di un ex sacerdote che per validi motivi Mussolini evitava di incrociare e si guardava dal nominare.
Poiché la storiografia si fonda sul vaglio di documenti anziché su frammenti di memorie spesso più difensive che oggettive, né si basa su elucubrazioni e fantasiose illazioni, Cacace separa scrupolosamente il grano dei “fatti accertati” dal loglio di quelli meramente “supposti”, con l’intento di rispondere alla domanda fondamentale sul 25 luglio 1943: chi davvero preparò e quando decise la sostituzione di Mussolini con Badoglio?
Al netto di progetti di minor portata e di propositi che si esaurirono o non ottennero alcun risultato pratico (rientrano in tale ambito i contatti instaurati tra la Principessa di Piemonte, Maria José, verosimilmente non all’insaputa del principe ereditario, Umberto, il sostituto segretario di Stato vaticano monsignor Giovanni Battista Montini e taluni notabili dell’antifascismo incluso Concetto Marchesi), fermo restando che i partiti (incluso il comunista) erano ancora del tutto privi di organizzazione adeguata e di effettiva incidenza sul corso degli eventi, le “cordate” principali in azione per il riassetto o il “cambio” al vertice del governo sono tre. Anzitutto i componenti del Gran consiglio del fascismo, la massoneria e i militari. Benché si possa parlare di “filiere” separate e preso atto che ciascuna di esse procedette nel massimo riserbo, ognuna ignara delle altre se non per cenni confidenzialmente scambiati tra taluni loro componenti, senza però che l’una conoscesse protagonisti e progetti dell’altra (farsi scoprire comportava finire agli arresti o peggio…), in una visione sintetica della loro trama si evince che tutte e tre facevano comunque conto sull’intervento risolutore del Re quale referente ultimo della loro iniziativa.
Procedendo per sommi capi e senza quindi privare il lettore del piacere di addentrarsi nei meandri esplorati da Cacace, la “cordata” più visibile e ripetutamente indagata fu quella allestita da Dino Grandi, conte di Mordano, proto-fascista, a lungo ambasciatore a Londra, presidente della Camera dei deputati, in convergenza con Giuseppe Bottai e con Luigi Federzoni, nazionalista, dal 1929 al 1939 presidente del Senato e massonofobo. Da quella prima intesa nacque la richiesta a Mussolini di convocazione del Gran Consiglio, dal 1928 elevato a “organo della rivoluzione fascista”, che non si radunava dal 7 dicembre 1939, cioè da prima dell’ingresso dell’Italia in una guerra che da “parallela” divenne via via “subalterna” rispetto a quella della Germania. Anche il filotedesco Roberto Farinacci, “ras di Cremona”, razzista oltranzista, e il chiassoso segretario del partito nazionale fascista, Carlo Scorza, si unirono nella richiesta della convocazione, suggerita da Vittorio Emanuele III a Grandi come “un surrogato del Parlamento”. Le Camere non venivano convocate neppure dinnanzi alla catastrofe militare imminente, a differenza di quanto era avvenuto nel novembre 1917, quando istituzioni e “politica” risposero al disastro di Caporetto con un governo nuovo e l’intervento solenne degli ex presidenti del Consiglio (Salandra, Boselli e Giolitti) in una seduta durante la quale Filippo Turati dichiarò che anche per i socialisti la Patria era sul Piave.
A differenza di quanto spesso ripetuto, l’ordine del giorno illustrato da Grandi alle 17 del 24 luglio dinnanzi al Gran Consiglio radunato nella sala del Pappagallo a Palazzo Venezia, in una Roma angosciata e deserta, non prospettò affatto la fine del fascismo, né (a differenza di quanto asserito da Emilio Gentile) l’“eutanasia del regime”, ma semplicemente l’assunzione del comando delle forze armate da parte del sovrano, la nomina di titolari dei ministeri militari (fagocitati da Mussolini, capo del governo e ministro dell’Interno e degli Esteri), l’appello alla resistenza militare in costanza delle istituzioni del regime, a cominciare dal Gran Consiglio stesso, e la configurazione del ruolo politico del duce, la cui sostituzione né Grandi né quanti approvarono il suo ordine del giorno (compreso Galeazzo Ciano, genero di Mussolini) esplicitamente proposero. Non per caso, dopo poche ore di sonno a Villa Torlonia, la mattina del 25 il duce tornò a Palazzo Venezia nella convinzione di avere ancora in pugno il governo del Paese. In quella convinzione sollecitò e ottenne udienza dal Re alle 17 a Villa Savoia, anticipando di poche ore quella ordinaria, prevista per l’indomani.
Per motivi di cui poco oltre diciamo, non è il caso di insistere sull’antica affiliazione massonica di parecchi componenti del Gran Consiglio e meno ancora di insinuare il massonismo di chi sino a prova contraria non fu mai iniziato. È il caso dei due quadrumviri superstiti, Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon ed Emilio De Bono.
Che Giacomo Acerbo, Giuseppe Bottai, Alfredo De Marsico (dal 1911), Roberto Farinacci, Giovanni Marinelli ed Edmondo Rossoni, in tempi remoti e per diversa durata, fossero stati in logge del Grande Oriente d’Italia (GOI) o della Gran Loggia d’Italia (GLI) non consente di dedurne che fossero in combutta in quanto massoni. Solo nel corso della seduta alcuni “fratelli” aggiunsero la loro alla firma dei proponenti originari. Indurre la consonanza di vedute tra gerarchi solo perché “figli della Vedova” (ovvero massoni) comporterebbe induzioni e deduzioni su fatti mai acclarati: anzitutto erano a conoscenza gli uni degli altri dell’antica militanza in Comunità contrapposte in contese poco fraterne e duramente competitive come quelle guidate da Domizio Torrigiani e da Raoul Palermi? Avevano, e quale, un abbozzò di progetto unitario che li accomunasse al quartetto Grandi-Federzoni-Bottai-Ciano, massonofagi o massoni pentiti? A profittare del loro pronunciamento, come Grandi stesso apprese con amarezza, sarebbe stato il successore in pectore di Mussolini, il maresciallo Badoglio che taluni, riecheggiati da Cacace, classificano “massone coperto” o “non dichiarato”, ma senza produrre alcun documento probante.
… e con le Stellette
Del pari, mentre è assodata l’iniziazione del maresciallo Ugo Cavallero (sia al GOI, sia alla GLI), notoriamente antagonista di Badoglio, il quale lasciò sulla scrivania in bella evidenza il “memoriale” che gli costò la vita (venne “suicidato” da Kesselring perché rifiutò di assumere il comando di un esercito italiano succubo dei tedeschi), del generale Giacomo Carboni e di altri minori protagonisti del “colpo di Stato”, come il generale Soleti e (molto importante) il Maresciallo Messe, caduto prigioniero degli inglesi e futuro capo di stato maggiore generale, manca qualunque prova di appartenenza massonica dei capi della “cordata” militare. Questa risultò la principale e vincente, in convergenza con il duca Pietro d’Acquarone, ministro della Real Casa di Vittorio Emanuele III. Essa fu incardinata sul capo di stato maggiore generale Vittorio Ambrosio e i suoi fidatissimi collaboratori, quale il giovane e fattivo Giuseppe Castellano, nessuno dei quali risulta massone, come non lo era il Maresciallo Enrico Caviglia benché pare che il Re non l’abbia preferito a Badoglio proprio perché non voleva si dicesse che la sostituzione di Mussolini riportava al potere la massoneria.
Meriterebbe un’ampia evocazione il ruolo svolto a ridosso del 24-25 luglio da Domenico Maiocco, capofila della Massoneria Italiana Unificata (biografato dal colonnello Antonino Zarcone), solerte tramite fra massoni, gerarchi di sicura sponda monarchica (come De Vecchi e Alfieri) e Ivanoe Bonomi, che guidava le forze antifasciste “aventiniane” con Marcelo Soleri (mai aventiniano né massone, a differenza di quanto afferma Cacace). Del pari va ricordato che il padre di Federico Comandini, nella cui abitazione venne fondato il Partito d’azione, era Ubaldo, repubblicano intransigente e massone nella loggia di Cesena. Insomma, a lungo costretta al sonno e con labili legami con le Comunità d’Oltrape, d’oltre Manica e oltre Atlantico, la massoneria in Italia, appena affiorante, non aveva affatto un progetto univoco.
Importa invece arrivare alla conclusione, cui conduce il materiale innovativo proposto da Paolo Cacace. Il vero regista del “cambio” fu l’impenetrabile Vittorio Emanuele III, unico vero interlocutore degli Alleati, in specie degli inglesi, consci che il sovrano era il garante della continuità dello Stato d’Italia, la cui legalità internazionale e interna poggiava su forze armate e corpo diplomatico.
Il disegno del Re era chiaro: ottenere che l’Italia potesse arrendersi e ottenere un “armistizio” (cioè la “tregua” delle armi) come il 9 settembre i giornali denominarono la “resa senza condizioni” (surrender), subita dopo le intricate trattative condotte da Giuseppe Castellano e firmate a Cassibile. Nello strumento della resa gli anglo-americani ordinarono all’Italia la “defascistizzazione”, altra cosa dalla “epurazione”, inventata per arruffate ragioni etiche da chi voleva scaricare sulla sola Corona il passivo della guerra e far dimenticare di aver votato a favore di Mussolini o di essere longa manus di Stalin.
Non fu “colpo di Stato”
Il 25 luglio fu dunque un “colpo di Stato”? La risposta è no. Vittorio Emanuele III esercitò il potere secondo l’articolo 65 dello Statuto: “Il Re nomina e revoca i suoi ministri”. Come a suo tempo osservò Luigi Einaudi, monarchico e presidente della Repubblica, il Re mostrò che “la prerogativa sovrana può e deve rimanere dormiente per lunghi decenni e risvegliarsi nei rarissimi momenti nei quali la voce unanime, anche se tacita, del popolo gli chiede di farsi innanzi a risolvere una situazione che gli eletti del popolo da sé non sono capaci di affrontare o per stabilire l’osservanza della legge fondamentale, violata nella sostanza, anche se osservata nell’apparenza”. L’Italia non era una “diarchia”, ma una “monarchia costituzionale”. Il Re fece quel che la Camera dei fasci e delle corporazioni, prona al duce, non seppe intraprendere. Venne implicitamente sollecitato dai 63 senatori che il 22 luglio chiesero la convocazione della Camera Alta. Il Gran Consiglio operò solo da “surrogato”. Cinque suoi componenti, condannati per alto tradimento, pagarono con la vita al Poligono di tiro di Verona per squallida vendetta di chi cercava tardivi meriti agli occhi di Hitler… Va loro tributato rispetto per quella iniqua fine, che non è l’ultimo dei motivi del sanguinoso epilogo della Repubblica sociale italiana. Alle 17 del 25 luglio 1943 Vittorio Emanuele III si era fatto garante della sicurezza personale del duce, che infatti non venne “arrestato” ma “fermato” e per scritto si dichiarò pronto a collaborare con Badoglio. Poi la storia ebbe altro corso…
FONTE: https://www.pensalibero.it/dossier-25-luglio-1943-fu-colpo-di-stato/
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°












